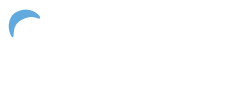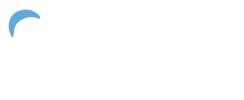Il Senato ha approvato la riforma costituzionale che introduce la separazione delle carriere tra magistrati “giudicanti” (i giudici) e magistrati “requirenti” (i pubblici ministeri).
Con 106 voti favorevoli, 61 contrari e 11 astenuti, l’Aula di Palazzo Madama ha dato il via libera al disegno di legge sulla revisione costituzionale riguardante l’ordinamento giudiziario.
Si tratta di un passaggio importante nell’iter legislativo: dopo l’approvazione alla Camera (primo via libera a gennaio 2025), il testo torna ora alla Camera per un ulteriore passaggio e, se non sarà raggiunta la maggioranza qualificata dei due terzi, sarà necessario un referendum confermativo.
Cosa prevede la riforma: punti chiave
Ecco i principali cambiamenti introdotti dalla riforma:
I magistrati giudicanti e i magistrati requirenti non faranno più parte dello stesso percorso professionale: viene definita una distinzione costituzionale fra funzioni di accusa e funzioni di giudizio.
Vengono istituiti due organi di autogoverno distinti: un Consiglio Superiore della Magistratura – magistratura giudicante per i giudici, e un Consiglio Superiore della Magistratura – magistratura requirente per i pubblici ministeri.
Viene creata un’Alta Corte Disciplinare per la magistratura, con competenze disciplinari nei confronti di magistrati giudicanti e requirenti.
Le modifiche riguardano la Costituzione, in particolare il Titolo IV sull’ordinamento giudiziario, rendendo necessarie più letture parlamentari e, potenzialmente, il referendum.
La maggioranza di governo sostiene che la riforma serva a garantire una magistratura più indipendente, senza “passaggi” tra funzioni di pm e funzioni di giudice; spezzare il legame fra organi giudicanti e requisitori per evitare possibili condizionamenti o conflitti di ruolo e favorire una giustizia percepita come più equa, efficace e trasparente per i cittadini.
La riforma è stata fortemente contestata da diverse associazioni della magistratura, opposizioni e parti della dottrina, che segnalano il rischio che la separazione delle carriere limiti l’unità della cultura giudiziaria e della funzione giurisdizionale. Desta preoccupazione anche il fatto che l’istituzione dell’Alta Corte Disciplinare possa ridurre le garanzie di difesa per i magistrati e incidere sull’indipendenza della magistratura. Il timore che la riforma non affronti temi centrali come l’efficienza dei processi, la dotazione di organico, la digitalizzazione, che i critici ritengono più urgenti.
Cosa significa per cittadini e magistrati
Per i cittadini la riforma potrebbe modificare l’assetto istituzionale della magistratura, con l’obiettivo di rendere la giustizia più autonoma e i ruoli più chiari. Tuttavia, gli effetti concreti sulla rapidità dei processi o sulla qualità della giustizia non sono immediati e dipenderanno dall’attuazione operativa.
Chi entra nella magistratura dovrà scegliere tra carriera da giudice o da pubblico ministero; non sarà più possibile passare liberamente da un ruolo all’altro come accade oggi.
Per l’ordinamento giudiziario si va verso un modello in cui i poteri e i percorsi professionali sono separati, con l’obiettivo di ridurre la commistione tra funzioni di accusa e giudizio, e potenzialmente ridurre il peso delle correnti interne alla magistratura.
Il testo ora torna alla Camera per un’ulteriore lettura; se non sarà raggiunta la maggioranza qualificata dei due terzi, dopo l’ultimo passaggio al Senato, sarà necessario un referendum confermativo — probabilmente nella primavera del 2026.
In conclusione: la riforma rappresenta un cambiamento significativo nell’assetto costituzionale della giustizia italiana, con promettenti obiettivi di maggiore chiarezza e autonomia. Ma resta aperta la questione dell’efficacia reale e della piena salvaguardia delle garanzie.