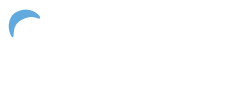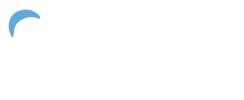Una recente indagine condotta nelle scuole primarie ha dimostrato che gli
Una recente indagine condotta nelle scuole primarie ha dimostrato che gli
insegnanti sono di fatto lasciati soli nella gestione delle “emergenze
sanitarie”, e nella maggior parte dei casi mancano competenze specifiche.
In più del 60% dei casi, i docenti non sanno dunque come intervenire se un
bambino accusa un malore. Un tema che già da tempo è stato sollevato dalla
Federazione Italiana dei Medici Pediatri (FIMP), che non vuole accettare
di sottoporre i piccoli studenti a quello che il vicepresidente nazionale
Antonio D’Avino (e segretario della sezione partenopea) ormai definisce un
rischio oggettivo.
«Facciamo nostre le preoccupazioni degli insegnanti e di quei genitori che
hanno figli con patologie croniche – dice D’Avino – patologie quali ad
esempio l’epilessia o il diabete. Genitori che ormai vivono le ore della
scuola con ansia e con la paura di ricevere una telefonata. Anche in
situazioni banali, come nel caso di semplici convulsioni febbrili, basta
non farsi prendere dal panico. Per queste ed altre situazioni sarebbe
fondamentale codificare delle procedure di intervento».
E’ poi Raffaella de Franchis, vicesegretaria FIMP Napoli, a spiegare che
«tra le richieste che spesso i genitori sottopongono al pediatra di
famiglia vi è il certificato con l’indicazione della modalità di
somministrazione di un farmaco antiepilettico, in caso che si verifichi
una crisi durante l’orario scolastico. La preoccupazione che la catena di
emergenza scolastica non sia adeguata e che il proprio figlio possa
correre dei rischi, durante un’eventuale fase acuta della sua patologia,
lascia in ansia numerose famiglie. D’altra parte, la presenza di una
patologia, come quella epilettica, non deve assolutamente minare il
diritto allo studio del bambino». A differenza della gestione terapeutica
della malattia nella sua fase cronica, che prevede l’utilizzo di farmaci
ad orari e con modalità prestabilite, la terapia in acuto richiede
competenze ed esperienza che nella maggior parte dei casi nelle scuole
mancano.
Per questa ragione la FIMP Napoli ha richiesto e avviato da tempo percorsi
di collaborazione con il mondo della scuola. «Nel 2009 – dice de Franchis
– dalla proficua collaborazione Fimp Napoli-Miur Campania, nacque un
vademecum sulle certificazioni mediche in ambito scolastico, ancora oggi
molto utilizzato, e che ha rappresentato una preziosa guida sia per i
pediatri di famiglia sia per i dirigenti scolastici. Oggi sarebbe
necessaria una nuova collaborazione, con l’obiettivo di definire una
regolamentazione concordata e sostenibile per la gestione di emergenze
mediche in ambito scolastico».
L’epilessia è solo un esempio, ma gli stessi problemi esistono anche con
l’ipo/iperglicemia nei bambini diabetici o la crisi di asma negli
asmatici, tanto per citare alcuni dei casi possibili.
«Gli attori di questo percorso condiviso – aggiunge la pediatra –
dovrebbero essere le famiglie, la scuola ed il pediatra di famiglia. Il
rationale dovrebbe essere l’adozione di comportamenti uniformi in tutte le
realtà scolastiche. La somministrazione dei farmaci in queste situazioni
acute, pur dovendo derivare da specifiche autorizzazioni fornite dal
pediatra, non richiede il possesso di cognizioni specialistiche di tipo
sanitario, né l’esercizio della discrezionalità tecnica da parte
dell’adulto. Quello che serve sono opportuni, adeguati e specifici corsi
di formazione per gli insegnanti, proprio per garantire una
standardizzazione di intervento, rendendoli consapevoli anche dei criteri
e dei tempi in base ai quali ci si deve rivolgere al servizio di
emergenza. Conoscere le diverse tipologie di epilessia, quali posizioni di
sicurezza far assumere all’alunno, quale eventuale intervento
farmacologico, indicato dal pediatra di famiglia, attuare e anche cosa non
fare per peggiorare la situazione, sono tutti aspetti che dovrebbero far
parte del bagaglio culturale degli insegnanti, per far sì che la crescita
psico-relazionale dell’alunno risulti adeguata e supportata dalla fiducia
e serenità delle famiglie».