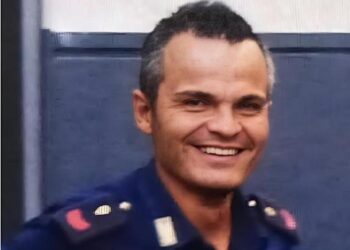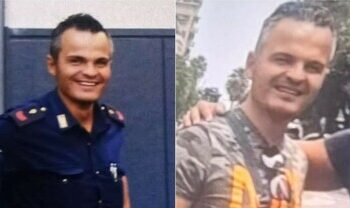Il Tribunale Ecclesiastico Metropolitano Penale dell’Archidiocesi di Milano ha assolto il parroco di Ponticelli Don Silverio Mura, accusato nel 2010 da Arturo Borrelli di aver abusato sessualmente di lui quando era un bambino. Borrelli ha conosciuto Don Mura tra i banchi di scuola, era il suo insegnante di religione.
Il Tribunale Ecclesiastico Metropolitano Penale dell’Archidiocesi di Milano ha assolto il parroco di Ponticelli Don Silverio Mura, accusato nel 2010 da Arturo Borrelli di aver abusato sessualmente di lui quando era un bambino. Borrelli ha conosciuto Don Mura tra i banchi di scuola, era il suo insegnante di religione.
A diramare la notizia è l’avv. Stefano Bartone, difensore di don Mura, che ha anche inviato agli organi si stampa la sentenza definitiva, emessa lo scorso 6 marzo, che assolve pienamente il sacerdote.
Gli atti a carico di don Silverio Mura furono trasmessi dalla Curia napoletana al tribunale della diocesi lombarda nel luglio scorso, dopo che il Papa decise di riaprire il caso. Il processo ecclesiastico penale era stato promosso dalla Congregazione per la dottrina della fede.
L’assoluzione del sacerdote napoletano arriva dopo quattro anni di istruttoria, gettando nello sconforto le due presunte vittime che a distanza di più di 20 anni, puntano il dito contro il sacerdote.
Una sentenza che potrebbe essere ribaltata, in ogni caso, in sede civile, dove si svolgerà un altro processo per un eventuale risarcimento dei danni.
Una vicenda che fin da subito ha diviso l’opinione pubblica e in particolar modo gli abitanti di Ponticelli, la comunità in cui Don Mura ha vissuto e lavorato per tanti anni .
Uno scenario controverso, dunque, perché se su un fronte il sacerdote ha adottato un comportamento ambiguo, sull’altro i suoi accusatori non si sono rivelati tanto più attendibili.
Se il sacerdote di Ponticelli non ha commesso gli abusi, infatti, andrebbe chiarito perché venne trasferito dalla curia di Napoli sotto falso nome a Montù Beccaria, un paese in provincia di Pavia, dove gli era consentito di fare catechismo, permettendogli così anche di interagire con i bambini, mentre all’ombra del Vesuvio fu reso noto che era stato mandato in un convento “a curarsi”.
Così come resta da chiarire se la malformazione al pene alla quale le due presunte vittime fanno riferimento sia stata accertata – rilevabile solo con il pene in erezione – e, in tal caso, in che modo il sacerdote abbia giustificato il fatto che due bambini siano venuti a conoscenza di un particolare tanto intimo.
Altro interrogativo legato alla figura del sacerdote è l’ingente quantitativo di denaro di cui disponeva e che gli permetteva di elargire di continuo regali costosi alle presunte vittime: completi delle squadre di calcio, biciclette, scooter e molto altro. Un tenore di vita in forte distonia con il suo status di semplice insegnante, proveniente da una famiglia modesta.
Infine, quando Arturo Borrelli, il principale accusatore del prete, lo incontra a distanza di anni, filmando quell’incontro con una videocamera nascosta, Don Mura non fa nulla per difendersi dalle accuse di pedofilia né tantomeno ha querelato il Borrelli per averlo ingiuriato e diffamato pubblicamente e in più circostanze.
Sul fronte delle vittime, invece, emergono una serie di fatti che possono concorrere a chiarire il contesto in cui è maturata la decisione del tribunale Ecclesiastico di Milano di assolvere il prelato.
In una mail inviata alla curia di Napoli, poco dopo lo shock traumatico che gli avrebbe consentito di rielaborare il trauma subito da ragazzino, Arturo Borrelli, che all’epoca lavorava come guardia giurata, minacciava di suicidarsi davanti alla curia partenopea con l’arma di ordinanza. Secondo quanto riferito dalla curia, con l’intento di preservare l’incolumità del Borrelli e della collettività, quella mail fu inoltrata alla Questura di Napoli, determinando il licenziamento della presunta vittima.
Una condotta mai violenta, ma spesso ingestibile, quella adottata dal Borrelli nel corso degli anni in cui ha portato avanti la sua battaglia per rivendicare giustizia. Una battaglia portata avanti soprattutto sui social e attraverso i social, dove sovente il Borrelli indirizza imprecazioni e maledizioni al cardinale Sepe, giungendo ad additarlo come il responsabile delle sofferenze patite, fino al giorno della morte, dal figlio 18enne, sopraggiunta in seguito ad un incidente stradale avvenuto lo scorso giugno in via Mastellone a Barra. Nonostante la curia partenopea si sia fatta carico di tutte le spese relative ai funerali del giovane, il Borrelli si è guardato bene dal rendere nota questa notizia e anche pochi minuti prima di dare l’estremo saluto al figlio, è salito sul pulpito dell’altare per inveire contro coloro che apostrofa come “gli artefici di tutti i suoi mali”.
Ben più rilevanti, invece, le incongruenze che emergono dalla testimonianza di Giuseppe Scognamiglio, nome di fantasia della seconda presunta vittima, che accusa Don Mura di essersi servito di lui anche come corriere di armi e droga.
Nel corso di una lunga intervista registrata lo scorso aprile, infatti, Scognamiglio riferisce che negli anni in cui Don Silverio passò alla parrocchia del comune vesuviano di Pollena Trocchia, oltre ad abusare sessualmente di lui, lo obbligava a recarsi in bici fino a Ponticelli per consegnare ad una donna un misterioso zainetto in cui gli riferiva che fossero contenuti dei libri di religione.
Un percorso di circa cinque chilometri, complessivamente dieci tra andata e ritorno, che il ragazzino avrebbe compiuto “2 o 3 volte a settimana, per circa due anni” e poi precisa: “lo avrò fatto una decina di volte in tutto”. Pertanto, – se la matematica non è un’opinione – i conti non tornano.
Da Pollena Trocchia a Ponticelli in bicicletta per raggiungere un luogo ben preciso: il Rione De Gasperi, la roccaforte del clan Sarno, all’epoca dei fatti. In quegli anni, i Sarno, partendo proprio dalla “torre di controllo” costruita nel rione che per anni ha funto da fortino del clan, con una serie di alleanze, unitamente all’utilizzo di metodi camorristici efferati, riuscirono ad imporsi sull’intera periferia orientale di Napoli, oltre che sull’entroterra vesuviano, spingendosi fino al cuore del centro storico partenopeo.
In quegli anni, i Sarno, non erano “un” clan, ma “il” clan. Tutte le dinamiche malavitose del territorio erano riconducibili alla cosca fondata dai fratelli Giuseppe, Vincenzo, Ciro e Luciano Sarno.
Scognamiglio riferisce che i suoi viaggi terminavano proprio lì, nella roccaforte del clan più temuto e temibile dell’epoca. Seppure sia in grado di descrivere minuziosamente l’abitazione del sacerdote, nella ricostruzione del percorso compiuto da “corriere inconsapevole”, non è in grado di fornire dettagli altrettanto attendibili, apparendo nervoso e contraddittorio.
Sostiene che il sacerdote gli avrebbe mostrato nel corso di un viaggio in auto il percorso che avrebbe dovuto compiere, invitandolo a non fermarsi mai lungo la strada, per poi indicargli la donna alla quale doveva consegnare lo zaino.
Il viaggio sarebbe terminato, dunque, in una zona del rione dove si rileva la presenza di un grosso spiazzale, attualmente semideserto, in seguito all’avvio del piano di riqualificazione del rione. Negli anni in cui si sarebbero svolti i fatti narrati, invece, il De Gasperi viveva il suo momento di massimo splendore, soprattutto perché nel cuore di quello spiazzale vi erano una scuola ed una chiesa, perennemente frequentate. Allo stato attuale, la scuola è occupata abusivamente da una famiglia che l’ha adibita ad abitazione e la chiesa è stata chiusa e ripetutamente vandalizzata, in quanto rientrante nel piano di abbattimento. Scognamiglio, nella sua ricostruzione, non menziona la presenza di due edifici tanto voluminosi quanto iperfrequentati in quegli anni e quando gli viene fatto notare, sorpreso e stupito chiede: “veramente là ci sta una chiesa!?”
Quella di Scognamiglio somiglia molto alla ricostruzione di un ragazzino abbastanza informato sulle dinamiche camorristiche del quartiere in cui vive e che da uomo torna a Ponticelli con un enorme gap culturale ed emotivo da colmare: quello relativo al nuovo e caotico disegno criminale consequenziale al pentimento delle figure-simbolo del clan Sarno.
In effetti, Scognamiglio ha trascorso molti anni lontano da Napoli, non a caso, proprio gli anni in cui i fratelli Sarno decisero di passare dalla parte dello Stato e solo pochi mesi dopo il suo ritorno a Ponticelli, mentre sentiva una giornalista fare domande sul presunto prete pedofilo del quartiere, si è reso conto di essere “la persona che quella giornalista stava cercando”.
In sostanza, la descrizione geografica e la ricostruzione storica proposte dalla presunta vittima, trovano riscontro nell’epoca contemporanea, come se “a caccia di elementi utili” per rendere credibile la pesante accusa, Scognamiglio effettivamente si sia recato nel rione. Oggi, per l’appunto, e non 20 anni fa.
La presunta vittima, afferma di aver scoperto per caso, un giorno, il reale contenuto dello zainetto che gli era richiesto di trasportare. Decise di fermarsi, – secondo quanto dichiara – perchè insospettito dall’eccessivo peso dello zaino, quindi ne sbircia il contenuto e così avrebbe rilevato la presenza dei panetti di droga, avvolti in nastro isolante marrone, e delle pistole, avvolte negli asciugamani. Scognamiglio mima anche minuziosamente il modo in cui erano ripiegati gli asciugamani in cui erano occultate le pistole. Come fa a conoscere alla perfezione il verso in cui erano chiuse, se sostiene, invece, di averle aperte e per giunta una sola volta?
Inoltre, proprio mentre ricostruisce quei fatti, nel corso dell’intervista, Scognamiglio ricorda di aver visto anche una bomba all’interno di quello zaino, asserendo che potrebbe essere verosimile, dato che pochi giorni prima, proprio attraverso le pagine del nostro giornale, aveva appreso del ritrovamento di alcuni ordigni bellici in un arsenale della camorra, provenienti dalla ex-Jugoslavia.
Infine, Scognamiglio sostiene di ricordare bene l’identità della donna alla quale il sacerdote gli avrebbe indicato di consegnare lo zainetto: la mamma dei “fraulella”, ovvero i fratelli Antonio e Giuseppe D’Amico, reggenti dell’omonimo clan, oltre che di Annunziata D’Amico, la donna-boss giustiziata nell’ottobre del 2015, dopo aver preso il posto dei fratelli al comando dell’organizzazione criminale, in seguito alla loro carcerazione.
I fratelli “fraulella”, in effetti, intraprendono la carriera camorristica come reclute del clan Sarno, per poi fondare un sodalizio autonomo in concomitanza dei primi segni di cedimento palesati dai fratelli Sarno, quando scelgono di passare dalla parte dello Stato.
Un nome attendibile, quindi, quello della “mamma dei fraulella”, che potrebbe rivelarsi utile a rafforzare il quadro accusatorio contro Don Mura. Tuttavia, Scognamiglio, ignora un dettaglio tutt’altro che trascurabile: la madre dei fratelli D’Amico non solo non ha mai vissuto nel Rione De Gasperi, ma soprattutto osteggiava fortemente l’ascesa criminale dei figli. Tra madre e figli, infatti, i litigi accesi erano all’ordine del giorno, tant’è vero che i figli Antonio e Giuseppe accusavano la madre di essere una “spia” della polizia, disposta a tutto pur di sottrarli al loro destino, anche “venderli” alle forze dell’ordine. Era la sorella Annunziata a fare da tramite tra madre e figli. Cercava di mediare, “la passillona”, questo il soprannome della donna-boss del clan D’Amico, consegnando ai fratelli i messaggi ricchi di rabbia e paura della madre. Eppure, nemmeno Annunziata è riuscita a sottrarsi al fascinoso richiamo della malavita.
Inoltre, incrociando le informazioni derivanti da fonti investigative con le testimonianze rese dai collaboratori di giustizia, si delinea uno scenario ben più ampio in termini di traffici illeciti, con il porto di Torre del Greco completamente alla mercè dei Sarno. Informazioni preziose ed attendibili che aiutarono gli inquirenti a scardinare il “sistema Sarno” in tal senso, furono rese da Anna Sodano, collaboratrice di giustizia uccisa dal clan, il cui corpo non è mai stato ritrovato.
Scognamiglio precisa che anche in altre circostanze si sarebbe recato nel Rione De Gasperi in compagnia di Don Mura: quando il sacerdote veniva convocato per dare l’estrema unzione alle reclute del clan vittime di agguati e pertanto impossibilitate ad entrare in chiesa per la celebrazione liturgica dei funerali.
La presunta vittima dichiara di non aver mai visto i cadaveri, perché Don Mura entrava da solo, lasciandolo all’ingresso della stanza con il turipolo dell’incenso tra le mani. In merito a questi fatti, non vi è riscontro in chiave investigativa né tantomeno i collaboratori di giustizia confermano l’esistenza di questo rituale, fosse anche solo per le difficoltà insite nel prelevare un cadavere dal luogo dell’agguato. Una ricostruzione che manifesta forti analogie con la scena con la quale si apre la terza serie di “Gomorra”, andata in onda in prima Tv su Sky nel novembre del 2017, quindi pochi mesi prima dell’intervista rilasciataci da Scognamiglio.
La presunta vittima sostiene anche che il sacerdote, dopo gli abusi sessuali, era solito svolgere due pratiche: regalargli soldi e fumare quella che lui definiva “la sigaretta puzzolente”, ovvero, uno spinello.
Alle anomalie fin qui elencate, aggiungiamo un altro tassello importante: la stampa nazionale ha definito quello contro Don Mura “il processo più grande della storia della Chiesa per numero di vittime”. Secondo quanto dichiarato dall’avvocato di Arturo Borrelli, sarebbero almeno 10 le “vittime accertate”.
Perché nella sentenza si fa riferimento solo a due persone?
In seguito alla risonanza mediatica assunta dal “caso Don Mura”, diverse persone, attraverso messaggi inviati sui social, hanno confidato a “Rete l’abuso” di aver subìto lo stesso trattamento in tenera età dal sacerdote, precisando, però, di non voler testimoniare né di voler essere chiamate in causa in nessun altro modo. Una prova che non può assumere alcun valore giuridico, quindi.
Lo stesso avvocato del Borrelli, in presenza di altre due persone, chiedeva al direttore di questo giornale, la giornalista Luciana Esposito, di divulgare un comunicato in cui esortava le presunte vittime del sacerdote a contattare la redazione per raccontare la loro storia. Aggiungendo poi che, di lì a poco, avrebbe pubblicato un ulteriore comunicato in cui rendeva noto di aver raccolto le testimonianze di altre otto vittime, così da “spaventare la curia di Napoli”.
Quanto riportato in questo articolo rappresenta una buona parte della testimonianza resa dalla giornalista Luciana Esposito, ascoltata dalla Curia di Napoli come persona informata dei fatti nel giugno del 2018, e inviata al Tribunale ecclesiastico di Milano.