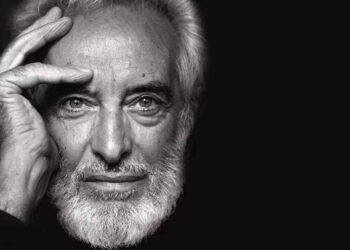La storia di Mariano Abbagnara, il baby boss, “guaglione” di fiducia, o forse no, dei Fraulella, ovvero il clan D’Amico, inizia nel Rione Conocal di Ponticelli.
La storia di Mariano Abbagnara, il baby boss, “guaglione” di fiducia, o forse no, dei Fraulella, ovvero il clan D’Amico, inizia nel Rione Conocal di Ponticelli.
E’ lì che è cresciuto, Mariano, mentre i genitori lavoravano nel ristorante di famiglia nel nolano, per non fargli mancare nulla. Era lì che vivevano i nonni, anziani e inconsapevoli delle insidie che si celavano dietro l’angolo per quel nipotino che, di certo, non era “cattivo”.
E’ così che si è perso, Mariano, inciampando in quelle “cattive amicizie” dalle quali tutti i genitori cercano di tenere alla larga i loro figli. I genitori di Mariano non potevano sapere, perchè non potevano vedere né immaginare che, lontano dalla loro guida, avrebbe perso la bussola.
Come tutti i bunker di un clan camorristico, anche il Conocal ha le sue regole e le sue insidie. Per tanti anni è stato un vero e proprio campo di guerra, come dimostravano i giubbotti antiproiettile e le armi nascoste tra le scale e all’interno dei vani dell’ascensore o dei contatori della luce, perché, come in ogni arsenale che si rispetti, quando meno te l’aspetti può essere necessario impugnare le armi per combattere l’ennesima battaglia di quella sanguinaria guerra senza fine, insorta nel segno della camorra.
Piazze di spaccio per strada: tra un palazzo e l’altro, nel bel mezzo dei cortili, tra i bambini che giocano. Per questa ragione, per i ragazzi che nascono e crescono in quel contesto, viene concepito e vissuto come un lavoro “normale”, l’unico al quale aspirare, l’unico che “offre un futuro” a quei giovani, disagiati e isolati dal resto del mondo. Il rione è un piccolo, grande regno, dove non regnano le leggi dello Stato, ma quelle della strada.
 Quei ragazzini, sono cresciuti per lo più adottati dalla “Passillona”, alias Annunziata D’Amico, sorella del leggendari Fraulella, prima donna ad aver ereditato le redini del clan quando i fratelli vennero arrestati. La Passillona è stata una figura centrale, carismatica, altamente significativa: madre adottiva di tutti i baby-gregari che altri non erano che i figli degli affiliati arrestati o uccisi per servire il clan o anche di quelli che i genitori li avevano, ma che in lei vedevano un’icona da venerare, servire e rispettare.
Quei ragazzini, sono cresciuti per lo più adottati dalla “Passillona”, alias Annunziata D’Amico, sorella del leggendari Fraulella, prima donna ad aver ereditato le redini del clan quando i fratelli vennero arrestati. La Passillona è stata una figura centrale, carismatica, altamente significativa: madre adottiva di tutti i baby-gregari che altri non erano che i figli degli affiliati arrestati o uccisi per servire il clan o anche di quelli che i genitori li avevano, ma che in lei vedevano un’icona da venerare, servire e rispettare.
Mariano è un giovane irretito ed affascinato dal richiamo delle “pistole potenti” e dei soldi facili e, ancor più da quei valori impartiti ai figli della camorra: onore, servilismo, rispetto, nessuna pietà per chi tradisce, per “le spie”, per “gli infami” e per “le guardie”. Essere disposti a dare anche la vita per servire il sistema e distruggere tutto e tutti coloro che possono essere identificati come “nemici”: concetti semplici ed estremi, efficaci ad addestrare perfetti ed irrecuperabili “soldati della camorra”.
 Mariano, detto “faccia janca”, in carcere ci è finito per aver ucciso Raffaele Canfora, un ragazzo di 25 anni, personaggio che gravitava negli ambienti del gruppo della Vanella Grassi di Secondigliano, prima picchiato, poi punito con tre colpi di pistola e infine lasciato morire tra un’atroce agonia e disperate richiesta di pietà.
Mariano, detto “faccia janca”, in carcere ci è finito per aver ucciso Raffaele Canfora, un ragazzo di 25 anni, personaggio che gravitava negli ambienti del gruppo della Vanella Grassi di Secondigliano, prima picchiato, poi punito con tre colpi di pistola e infine lasciato morire tra un’atroce agonia e disperate richiesta di pietà.
Mariano, all’epoca dei fatti, aveva 17 anni.
Raffaele era un suo amico, ma le regole della camorra vengono prima di tutto e chi sceglie quella strada, forse è consapevole di non avere amici, proprio per questo motivo. Raffaele, forse, lo ha capito mentre sentiva la sua vita spegnersi in quella lenta e straziante agonia.
Raffaele viene ucciso “regolare” degli attriti tra gruppi camorristici per il controllo dello spaccio di droga nell’area est di Napoli. La sera dell’omicidio, fu lo stesso Raffaele a prelevare in auto Mariano e i suoi ‘amici-carnefici’ dal rione Conocal di Ponticelli. Da Marianella – il quartiere in cui abitava – a Ponticelli, era giunto a bordo della sua Panda, per andare inconsapevolmente incontro alla morte. Con loro si spostò a Ercolano, dove fu ucciso.
I lamenti di Raffaele, mentre è in agonia, si sovrappongono alle note di una canzone. Gli spasmi, mentre affoga nel suo stesso sangue, si fanno sempre più flebili, mentre qualcuno cinicamente pompa il volume dell’autoradio che spara musica techno. Fino a quando il gemito si trasforma nel sussulto dell’ultimo respiro, tragicamente percepito e registrato grazie a un telefono cellulare che è sotto intercettazione: è così che i carabinieri ascoltano la morte in diretta di Raffaele Canfora, ucciso a soli 25 anni dopo essere finito nella trappola che gli hanno teso i suoi carnefici. «Lo abbiamo schiattato…», racconterà poi Raffaele Stefanelli, il complice 26enne di Mariano, nonché mente dell’omicidio, ad un altro pregiudicato, vantandosene e ignorando di essere intercettato. Impotenti, gli investigatori, riescono ad ascoltare tutto quella sera, perché i killer dopo aver sparato cominciano a usare in maniera forsennata il telefonino, ignari di essere spiati: e così sentono attimo dopo attimo la voce del ferito che implora inutilmente aiuto e pietà. Mentre gli assassini ascoltano musica.
Dopo avergli sparato, i suoi carnefici portano Raffaele in giro per circa un paio d’ore tra Terzigno e Ponticelli. La scoperta del cadavere in avanzato stato di decomposizione arriverà solo un mese dopo in una campagna di Maddaloni; è qui, sotto mezzo metro di terra che un cacciatore lo ritrova per un caso fortuito: un branco di cinghiali è riuscito a scavare lo strato di terreno e stava facendo scempio di parte del cranio. Anche la Panda viene ritrovata bruciata in un fondo rustico di Acerra.
Canfora venne ucciso per dodicimila euro: tanto valeva la vita di quel 25enne, ucciso dai suoi stessi amici. Il prezzo di una partita di hashish ceduta nelle mani sbagliate e mai più pagata.
A tanto ammonta il debito di Stefanelli nei confronti di Canfora, per una partita di hashish venduta, ma che il giovane di Ponticelli non ha mai pagato. Una cessione di droga venduta con la tecnica (sempre più frequente) del cosiddetto «passaggio di mano»: cioè ceduta da soggetto a soggetto per conto di due clan.
Il 6 marzo – undici giorni prima dell’omicidio – Canfora chiama Stefanelli: «Mi devi ancora quelle “cinque” lire…», dice. È solo l’inizio di una interminabile sequenza di contatti con i quali il venditore reclama l’importo mai versato dall’acquirente. Stefanelli di giorno in giorno si giustifica, cerca scuse: «Sto ancora aspettando i soldi», «Cerco di farmeli dare domani», è la risposta. In realtà il giovane di Ponticelli ha tenuto per sé quella partita di droga anziché cederla al clan D’Amico. Il gioco delle tre carte prosegue in un crescendo di tensioni che culminano nello sbocco di rabbia di Raffaele: «Se non mi date i soldi vengo io là (a Ponticelli, ndr) a prendermeli. E a quelli là metto una corda al collo!». A questo punto Stefanelli matura l’idea di uccidere il suo creditore. E si rivolge al 17enne Mariano Abbagnara – che solo il 2 maggio del 2015 diventerà maggiorenne – che subito si propone come complice. Non solo: il ragazzino è anche colui che nel Rione Conocal di Ponticelli si procura anche la pistola calibro 7,65 e – nel luogo dell’esecuzione – trattiene Canfora mentre l’altro gli spara al petto. Mariano, cresciuto nel bunker del clan D’Amico, sa bene dove reperire l’arma per uccidere Raffaele: nel vano ascensore, nascondiglio ed arsenale del clan.
È ancora Mariano – seppur minorenne – a guidare la Panda di Raffaele, traghettandolo tra Terzigno e Ponticelli, agonizzante, per più di due ore.
Non poteva guidare, secondo la legge dell’” altro” Stato e, invece, Mariano spingeva forte il piede sull’acceleratore tant’è vero che Stefanelli lo aveva redarguito più volte, intimandogli di andare piano. Mentre Stefanelli si reca dall’amante per costruirsi un alibi, Mariano si occupa della sepoltura, insieme ai due cognati e alla madre di Stefanelli.
Per l’omicidio di Raffaele Canfora finiscono in manette altre tre persone, oltre a Mariano e Stefanelli, ritenuti gli esecutori materiali: la madre di quest’ultimo, Patrizia Zinco e due suoi cognati, Gaetano Amato e Gennaro De Luca. Per tutti accuse pesantissime: concorso in omicidio aggravato dalle finalità camorristiche, distruzione e soppressione di cadavere, porto abusivo di armi.
Per quest’omicidio, che secondo la versione degli imputati sarebbe avvenuto all’insaputa del clan D’Amico, Mariano è stato condannato a 16 anni in secondo grado.
 Inizialmente, ha scontato la pena nel carcere minorile di Airola ed è tra i grandi protagonisti della “rivolta delle sigarette” che ha portato al ferimento di due agenti. nell’estate del 2016. Una rivolta inscenata da Mariano, probabilmente, per dimostrare “ai grandi boss” di essere pronto per “il salto di qualità”.
Inizialmente, ha scontato la pena nel carcere minorile di Airola ed è tra i grandi protagonisti della “rivolta delle sigarette” che ha portato al ferimento di due agenti. nell’estate del 2016. Una rivolta inscenata da Mariano, probabilmente, per dimostrare “ai grandi boss” di essere pronto per “il salto di qualità”.
Poi arriva la consacrazione mediatica: Mariano, nel corso del film-documentario Robinù, descrive “il kalash” – il kalashnikov – come una bella donna. Quel ragazzo è cresciuto nel segno di chi educa i figli insegnandogli che tenere un’arma potente tra le mani, una di quelle che sgancia “le botte” – i proiettili – grandi rende “il padrone”. È impressionante l’analogia concettuale che trapela accostando le dichiarazioni rilasciate da “faccia janca” davanti all’obiettivo, a quelle intercettazioni in cui Annunziata D’Amico fornisce ai suoi figli-gregari consigli utili sulle armi da utilizzare, esaltandoli ed incitandoli all’uso delle stesse.
Eppure, Mariano un kalashnikov tra le braccia non lo ha mai avuto. Lo confermano le fonti investigative, le forze dell’ordine che operano sul territorio e che conoscono le dinamiche camorristiche di Ponticelli e le evoluzioni maturate negli anni.
 Nel Rione Conocal, i baby-boss non sono mai esistiti. Non è necessario “essere un camorrista” per essere accettato e venerato da quel sistema, da quel tessuto sociale che recepisce di buon grado le odi alla malavita, quello che conta è l’immagine che si dà di sè agli altri e Mariano è ben riuscito ad emulare questo smanioso bisogno di apparire, raccontando la figura di sè che aveva creato nella sua mente, ma che non trovava riscontro nella realtà: la prima forte spinta verso “la consacrazione a boss” è arrivata attraverso i social, quando in seguito al suo arresto, amici e parenti lo dipingevano come un leone in gabbia, esortandolo a non mollare, sognando il suo grande ritorno tra i palazzoni grigi del Conocal per tornare a spadroneggiare.
Nel Rione Conocal, i baby-boss non sono mai esistiti. Non è necessario “essere un camorrista” per essere accettato e venerato da quel sistema, da quel tessuto sociale che recepisce di buon grado le odi alla malavita, quello che conta è l’immagine che si dà di sè agli altri e Mariano è ben riuscito ad emulare questo smanioso bisogno di apparire, raccontando la figura di sè che aveva creato nella sua mente, ma che non trovava riscontro nella realtà: la prima forte spinta verso “la consacrazione a boss” è arrivata attraverso i social, quando in seguito al suo arresto, amici e parenti lo dipingevano come un leone in gabbia, esortandolo a non mollare, sognando il suo grande ritorno tra i palazzoni grigi del Conocal per tornare a spadroneggiare.
Il processo per associazione a delinquere di stampo mafioso che vede imputato Mariano Abbagnara, attualmente ed è entrato nel vivo del dibattimento con l’esame dei collaboratori di giustizia.
La Suprema Corte di Cassazione ha annullato l’ordinanza emessa lo scorso 15 maggio dal Tribunale di Napoli che aveva a sua volta confermato che nei confronti del giovanissimo Abbagnara sussistevano gravi indizi della sua appartenenza al clan D’Amico di Ponticelli.
 Nel Rione Conocal, per certi ragazzi, i giorni passano tutti lenti e uguali: ridacchiando quando gli passa davanti una ragazza carina, abbozzando commenti ed apprezzamenti poco eleganti, schernendo i ragazzi che vanno a scuola o pettinati e vestiti in modo strano. Parlano di niente e fumano una quantità indecifrabile di canne. Giocano ai video-poker e alla play station, al biliardo nei circoli ricreativi o trascorrono ore seduti sulle ringhiere del rione o fuori ad un bar, a fumare, fumare, fumare e parlare di niente o della vita di strada. Poi arrivano “i grandi”: i coetanei che grandi non lo sono per gli anni che hanno, ma per la fama che hanno guadagnato. Gli mostrano “il ferro”, quella pistola di cui tanto blaterano quei ragazzi, persi e sbandati, annoiati e sempre meno istruiti. Gli fanno provare “la droga dei grandi”, i coetanei che grandi non lo sono per gli anni che hanno, ma per le droghe che possono permettersi.
Nel Rione Conocal, per certi ragazzi, i giorni passano tutti lenti e uguali: ridacchiando quando gli passa davanti una ragazza carina, abbozzando commenti ed apprezzamenti poco eleganti, schernendo i ragazzi che vanno a scuola o pettinati e vestiti in modo strano. Parlano di niente e fumano una quantità indecifrabile di canne. Giocano ai video-poker e alla play station, al biliardo nei circoli ricreativi o trascorrono ore seduti sulle ringhiere del rione o fuori ad un bar, a fumare, fumare, fumare e parlare di niente o della vita di strada. Poi arrivano “i grandi”: i coetanei che grandi non lo sono per gli anni che hanno, ma per la fama che hanno guadagnato. Gli mostrano “il ferro”, quella pistola di cui tanto blaterano quei ragazzi, persi e sbandati, annoiati e sempre meno istruiti. Gli fanno provare “la droga dei grandi”, i coetanei che grandi non lo sono per gli anni che hanno, ma per le droghe che possono permettersi.
 Salvatore De Bernardo classe 1990, arrestato nel maxi-blitz che a giugno del 2016 ha fatto scattare le manette per più di 90 affiliati al clan D’Amico, viene visto e vissuto come “un grande”, non solo per la stazza fisica e gli anni di differenza che intercorrono tra lui e quei ragazzini ai quali fa da chioccia. Tra loro c’è Mariano, come dimostrano le foto, i due sono inseparabili.
Salvatore De Bernardo classe 1990, arrestato nel maxi-blitz che a giugno del 2016 ha fatto scattare le manette per più di 90 affiliati al clan D’Amico, viene visto e vissuto come “un grande”, non solo per la stazza fisica e gli anni di differenza che intercorrono tra lui e quei ragazzini ai quali fa da chioccia. Tra loro c’è Mariano, come dimostrano le foto, i due sono inseparabili.
Proprio guardando le foto di Mariano nel passaggio da ragazzino ad “aspirante uomo” si denota un cambiamento eloquente: i tratti del viso, ingenui e teneri, iniziano ad irrigidirsi. I denti mettono in evidenza gli “effetti collaterali” degli stupefacenti. Gli occhiali da vista “da bravo ragazzo” lasciano il posto a quelli ben più in voga tra i giovanissimi e molto spesso vengono rimpiazzati da lenti scure, forse per camuffare i segni delle notti brave o degli stupefacenti di cui il giovane fa uso ed abuso.
Una dipendenza che il carcere non ha sedato: la scorsa settimana, gli agenti del carcere di Secondigliano dove attualmente il giovane è detenuto, grazie al fiuto di un cane antidroga, hanno trovato oltre 50 grammi di sostanza stupefacente, del tipo hashish, occultati negli slip di Mariano.
 La vita nel rione, tra i “cattivi ragazzi” del rione, alla quale si addiziona la vita in carcere, tra i “cattivi ragazzi” del carcere. E’ così che Mariano giunge al compimento del percorso che lo porta, con sorriso orgoglioso e irriverente, a rilasciare quella dichiarazione d’amore al “kalash”, quando gli accendono una telecamera in faccia.
La vita nel rione, tra i “cattivi ragazzi” del rione, alla quale si addiziona la vita in carcere, tra i “cattivi ragazzi” del carcere. E’ così che Mariano giunge al compimento del percorso che lo porta, con sorriso orgoglioso e irriverente, a rilasciare quella dichiarazione d’amore al “kalash”, quando gli accendono una telecamera in faccia.
Sotto il profilo processuale, dopo il secondo annullamento disposto dalla Suprema Corte di cassazione, si dovrà discutere per la terza volta innanzi al Tribunale del riesame di Napoli onde stabilire se sussistono o meno i gravi indizi in ordine alla appartenenza di Abbagnara al clan D’Amico.
Nel frattempo il processo di merito al clan D’Amico è in piena fase dibattimentale con udienza fissata giovedì 11 gennaio 2018 innanzi al Tribunale di Napoli.
Chi sarà Mariano Abbagnara quando uscirà dal carcere: un uomo riabilitato o un camorrista pronto ad occupare il suo posto in trincea?