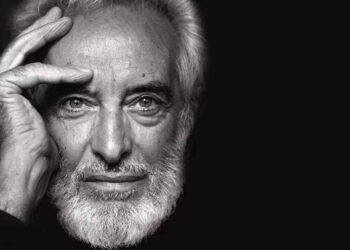“Al di là delle montagne”, in concorso a Cannes nel 2015 e vincitore dell’Asian Film Award per la miglior sceneggiatura, approda nelle sale italiane carico di aspettative da soddisfare. Jia Zhang-ke, apprezzatissimo regista cinese, già vincitore del Leone d’oro nel 2006 con “Still life”, prosegue il suo discorso sulla mutazione in atto nel suo paese, cercando la strada della sintesi filmica di storia e di previsione, tra passato, presente e futuro usando addirittura tre diversi formati fotografici (Dolan docet): un “Ieri , oggi e domani” in salsa cinese.
“Al di là delle montagne”, in concorso a Cannes nel 2015 e vincitore dell’Asian Film Award per la miglior sceneggiatura, approda nelle sale italiane carico di aspettative da soddisfare. Jia Zhang-ke, apprezzatissimo regista cinese, già vincitore del Leone d’oro nel 2006 con “Still life”, prosegue il suo discorso sulla mutazione in atto nel suo paese, cercando la strada della sintesi filmica di storia e di previsione, tra passato, presente e futuro usando addirittura tre diversi formati fotografici (Dolan docet): un “Ieri , oggi e domani” in salsa cinese.
E’ il 1999 nella piccola città di Fenyang, un gruppo di ragazzi festeggia il capodanno ballando sulle note di “Go West” dei Pet Shop Boys. Al centro della scena la giovane Tao. Su di lei gli sguardi innamorati dei suoi amici di infanzia Liangzi, sensibile lavoratore nella locale miniera, e di Zhang Jinsheng, giovane ambizioso e dalle mire imprenditoriali. Il regista sceglie quindi la sua città natale, la periferia, per l’analisi della trasformazione radicale che è avvenuta in Cina lasciando il passo ad un capitalismo imperante che fagocita le tradizioni più arcaiche partorendo illusioni collettive di cui soprattutto i giovani ne restano colpiti, in uno scenario naturalistico arido e lugubre, in cui si alternano miniere grigie, complessi industriali e scavi.
I volti ristretti in una ripresa in 4:3, su cui la macchina resta fissa per lunghi minuti, oltre a rallentare la narrazione fatta di poche e inconsistenti battute cerca di mettere a fuoco i personaggi, con scarsi risultati, non riuscendo mai infatti a strutturare le sfaccettature delle tre diverse personalità.
L’approssimativa disamina esistenziale ed evolutiva si muove attraverso uno sguardo che via via si “allarga”, passando dal formato 4:3, al 16:9, senza mai distogliere l’attenzione dai suoi protagonisti che ormai hanno perso il precedente carattere individuale, dissolvendosi all’interno delle società che vivono, poiché ciò che li circonda comincia a prendere il sopravvento. Ciò che li lega indissolubilmente, nonostante le differenze, è comunque un forte senso di alienazione emotiva e culturale: mentre Liangzi lascia la città di origine per sprofondare nella polvere di un’altra miniera, Jinsheng sposa e presto lascia Tao, portando con sé prima a Shanghai e poi in Australia il loro bambino, enfaticamente chiamato Dollar.
Poi il 2014, il processo di mutazione è narrato anche mostrando come sono cambiati consumi e abitudini e divertimenti collettivi, un’americanizzazione continua sulle note di “Take Care” di Sally Yeh. L’ultimo capitolo, il 2025, è sicuramente il più interessante, in una visione futurista del mondo si allarga la visione dello spettatore sia metaforicamente che visivamente.
Girato in 23:1, il dramma di una famiglia diventa il dramma collettivo di un popolo vessato dalla tragedia dell’incomunicabilità, in cui la coesistenza tra modernità e tradizione diventa un ostacolo: il giovane Dollar, alienato per la mancanza di profonde radici culturali, non riesce, letteralmente, a parlare con il padre se non tramite Google traslate. Il paesaggio ampio e dai colori sfumati dell’Australia diventa una prigione a cielo aperto, in cui le mura e le sbarre sono sostituite da alienazione e mancanza di ricordi.
Il tempo scorre e fagocita ogni cosa, l’individuo si dissolve e lascia spazio a ciò che c’è fuori da lui dimenticandosi di sé ed incapace totalmente di stringere legami (emblematico il rapporto edipico di Dollar con la sua insegnante). L’humanitas viene immolata all’altare del progresso, processioni di automi globalizzati ma perduti: Dollar è cittadino del mondo ma sostanzialmente di nessun luogo, Tao è lo spettro di un mondo scomparso e coperto di neve. L’ambizione del regista però non trasmette con la giusta convinzione e sensibilità il cambiamento, che era la premessa del film, di una donna, di una famiglia, del suo paese, non racconta in modo credibile e strutturato la metamorfosi di un popolo la cui intimità viene sbriciolata nell’impatto del capitalismo che ridisegna i confini della geografia dei sentimenti.
Non essendo a proprio agio evidentemente in una dimensione narrativa di cinema in cui l’intreccio e l’azione sono fondamentali, si avverte la fatica di un racconto in cui i fatti contano meno dei personaggi, in cui solo le premesse e la fotografia sono degne di nota.
“Al di là delle montagne” è una pellicola che non risplende, è come un fuoco d’artificio che non si può vedere poiché brilla in un cielo illuminato dal giorno.