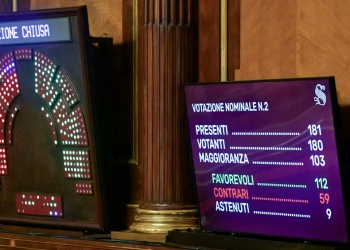La storia di “Nessuno” è la storia di tanti, di chiunque, quella che racconta le vicissitudini nelle quali si può imbattere un ragazzo qualunque, dei vicoli, delle periferie, cresciuto “miez’ a via” e pertanto costretto ad imparare prima a “schivare i colpi” – di qualsivoglia genere e natura – e poi a camminare.
La storia di “Nessuno” è la storia di tanti, di chiunque, quella che racconta le vicissitudini nelle quali si può imbattere un ragazzo qualunque, dei vicoli, delle periferie, cresciuto “miez’ a via” e pertanto costretto ad imparare prima a “schivare i colpi” – di qualsivoglia genere e natura – e poi a camminare.
Ragazzi nati già con il destino segnato: questa è la conclusione più scontata verso la quale propende l’immaginario collettivo.
E invece no.
Tra i vicoli e, più in generale, lungo quelle fatiscenti lingue d’asfalto che costeggiano perentori macigni di cemento dai quali trasudano muffa e degrado, il destino si diverte ad intrecciare i fili e a mischiare le carte per dare libero ed incontrastato sfogo a tutto il suo sadico cinismo.
“La curva, la vita sugli spalti, da sempre, riflette le gerarchie che esistono all’interno delle organizzazioni criminali.”
Così inizia il racconto di “Nessuno”: un ragazzo qualunque, un ragazzo come tanti, rimasto imbrigliato tra le beghe camorristiche proprio “grazie” all’amore per la squadra della sua città, il Napoli.
Per i giovani scugnizzi è una pratica tacita che si consuma di domenica in domenica e si tramanda di generazione in generazione, quella di entrare allo stadio raggirando “l’impiccio” di dover esibire il biglietto.
I tempi, tuttavia, rispetto all’illustre era maradoniana sono cambiati, sotto ogni aspetto. L’introduzione dei tornelli ha senz’altro reso tutto più difficile, anche per loro e anche in questi termini.
“Molto spesso capitava che io e i miei amici venivamo respinti dagli steward quando cercavamo di infilarci nei tornelli insieme a persone che avevano il biglietto. Anche se ci riuscivamo, una volta dentro, gli altri steward ci “catturavano” e ci buttavano di nuovo fuori. Loro, gli ultras, i capi, sono come dei giganti temuti e rispettati da tutti e grazie a loro, più di una volta, siamo riusciti ad entrare.
“E guagliune stann’ cu nuje”.
Dicevano agli steward e come se quella fosse una parola magica che ci rendeva “intoccabili”, entravamo anche noi con loro. Questo episodio si è ripetuto per diverse domeniche, io avevo 11 anni quando ho iniziato ad andare allo stadio ed ero il più piccolo, i miei amici avevano tra i 13 e i 14 anni. Ai miei occhi, quelle persone erano “grandi”, non solo perché lo erano tanto più di me fisicamente, lo erano per quello che potevano fare, per il potere che possedevano: l’intera curva, migliaia di persone eseguivano i loro ordini.
Quando ci mostrarono delle foto in cui erano insieme ai calciatori, ai nostri idoli, probabilmente, hanno capito che ci avevano in pugno e che potevano chiederci quello che volevano. Per noi ragazzini, cresciuti senza niente, non avevamo neanche la possibilità di comprare le figurine per guardare i nostri beniamini attraverso un album, sapere di conoscere delle persone “importanti” e che avevano delle amicizie così forti era motivo di “vanto”.
(“Quanto mi faccio schifo e mi vergogno, oggi, per quello che ho provato allora!” confessa “Nessuno” concedendosi un imprevisto pensiero estemporaneo.)
“Siamo grandi amici, andiamo a mangiare insieme quasi tutte le sere… qualche volta portiamo pure a voi”: queste le frasi che accompagnavano quella carrellata di foto.
“Dobbiamo diventare amici, però”. E “quell’amicizia” l’abbiamo pagata a caro prezzo.
Ci infilavano la droga che dovevano vendere nello stadio nei pantaloni, perché ormai era sicuro che le mani addosso a noi, gli steward non le avrebbero messe mai. Ero talmente piccolo che non capivo neanche cosa accadeva e cosa fosse quella roba. Una sera, di ritorno dallo stadio, lo raccontai a mio padre che mi gonfiò di botte, senza dire nemmeno una parola.
Lo avevo capito che mi stavo cacciando nei guai, ma non sapevo come uscirne, non avevo nessuno con cui parlarne.
I miei amici erano esaltatissimi da quel “nuovo giro” in cui eravamo entrati e raccontavano un sacco di bugie a tutti. Una volta dissero anche che dopo una delle rare partite in cui non riuscì ad andare allo stadio, i capi li avevano portati dalle prostitute, ma non ci ho mai creduto. Era una delle tante storie che gonfiavano per farsi belli con gli altri amici nostri.
Il passaggio da “dentro” a “fuori” fu praticamente immediato e ben presto ci trovammo a spacciare droga tra i nostri amici e non solo.
E io continuavo a non sapere neanche bene come fosse fatta precisamente quella roba e che cosa ci fosse appallottolato dentro a quella dose di cui, però, conoscevo prezzo, spedizione e dettagli simili, alla perfezione.
Un lavoro ben pagato, senza dubbio, ma che aveva consegnato troppi soldi e troppo presto in mani troppo piccole che facevano fatica a mantenerli. Abbiamo bruciato le tappe, tutte le tappe e quello che resta di me e degli amici miei, oggi, lo dimostra pienamente: chi è “rimasto sotto” dopo un brutto incidente con il motorino, chi entra ed esce dalla comunità, chi, come me, dopo essere stato arrestato per spaccio, colto in flagranza di reato, è stato sbattuto in galera e adesso, sta cercando di capire, come continuare a saldare il suo debito con la giustizia, senza bruciare del tutto l’idea di una vita libera, consapevole del fatto che non sarà facile trovare un lavoro onesto e dignitoso con la fedina penale sporca. No, non lo sarà affatto.
E poi ci sono quelli che hanno fatto carriera e che adesso sono camorristi a tutti gli effetti.
E pensare che allo stadio ci andavamo solo per guardare la partita.”