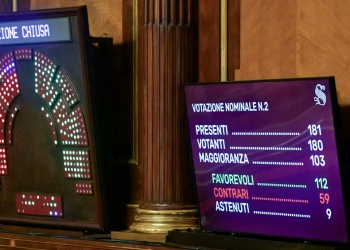Suggestivo, grottesco, crudo, crudeli, irreale e surreale e quel sovrapporsi di immagini che si inseguono a ridosso dell’ingresso – o dell’uscita, a seconda dei punti di vista – della stazione metropolitana di Piscinola.
Suggestivo, grottesco, crudo, crudeli, irreale e surreale e quel sovrapporsi di immagini che si inseguono a ridosso dell’ingresso – o dell’uscita, a seconda dei punti di vista – della stazione metropolitana di Piscinola.
Ad accogliere i pedoni che si apprestano a trasformarsi in passeggeri, vi è la più nuda e primitiva forma di disperazione, quella vera, quella che non conosce né dignità né alternative, quella dei tossici, pronti a propinare un “biglietto ancora utilizzabile, ad un prezzo stracciato”, capace di consentire all’acquirente di risparmiare qualche centesimo e al rivenditore di arrancare la cifra necessaria per assicurarsi la quotidiana dose di autodistruttiva e turpe acredine.
Quel veleno, divoratore di sogni e livore che, con cognizione di causa, i tossici scelgono di amalgamare con la loro stessa linfa, gli d’Europa serenità, anima e volto, conferendogli spiccati ed inconfondibili tratti somatici che gli imprimono un aspetto difficilmente equivocabile, una sorta di “maschera universale” che assume le parvenze di una “targa”, sulla quale, con stentoree e marcate lettere, vi è scritto: “sono un tossico”.
“Aurora” è una donna snella e slanciata, tuttavia, non è facile carpirne l’età, complice proprio quella maschera sfigurante che la droga le ha disegnato sul volto, unitamente ai grossi e scuri occhiali che indossa.
In ogni caso, sconcerta e stranisce, vedere “una come lei”, nervosamente elemosinare spiccioli, in cambio di un biglietto già marcato che si appresta a scadere con la stessa perentoria ed inarrestabile frenesia con la quale lei stessa si accinge ad andare incontro all’ennesima crisi d’astinenza, qualora non riuscisse a racimolare in tempo la somma necessaria per arginare quella compulsiva brama di droga.
Nonostante “Aurora” tenti di nascondere il famelico bisogno di farsi, dietro quei cupi ed ingombranti occhiali, la voglia di urlare il suo dramma quotidiano, che le è scolpita negli occhi, è talmente violenta da trasparire perfino attraverso quegli stessi enormi specchi neri.
Inizialmente, come “il copione” impone, prova a propinarmi le “solite storie da tossico”: “Devo comprare il latte per il mio bambino”, “Devo comprare le medicine per mia madre, gravemente malata”.
Poi, quel labile castello di fandonie, cade, inondato dalle sue stesse lacrime, con la medesima grossolana faciloneria con la quale, una prodigiosa onda, rade al suolo una roccaforte di sabbia, imprudentemente edificata a ridosso della riva.
Nel caso di “Aurora” sono state le crudeli circostanze che il destino ha cesellato nella sua vita a condannarla ad indossare i putridi abiti della tossica.
“Aurora” era iscritta al primo anno d’università, quando, un pomeriggio, aprendo la porta di casa, viene assalita dalla sconvolgente ed incancellabile immagine di sua madre, tramortita al suolo, accanto al cui corpo esanime, giaceva la siringa che aveva adoperato per intraprendere il suo eterno viaggio verso la morte.
Prima di quel momento, “Aurora” non aveva mai realmente carpito la gravità del dramma che straziava l’esistenza dalla sua genitrice e che, repentinamente, la stava divorando.
“Aurora” non aveva mai conosciuto suo padre, viveva con sua madre e, da qualche anno, con l’uomo che, dopo quella tragica sciagura, prepotentemente si erse a “padre, padrone”, impossessandosi di tutto: casa, soldi, potere decisionale e perfino della sua stessa vita.
Ben presto, infatti, quell’uomo, si tramuta da “patrigno” a “compagno”, seppur tanto più anziano, ma assai più “grande” di “Aurora”, smarrita, dilaniata dal dolore, troppo fragile, arrendevole, cascante, per opporsi ed osteggiare quel mostro che le stava violentando la vita, stroncandole ambizioni, progetti, serenità, imprimendo anche nelle sue vene quel labile ed esiguo “futuro a senso unico”.
Per quell’uomo, non esiste denaro utile per pagare la retta universitaria o per sostenere qualsivoglia altra “sensata” spesa, non riconducibile alla voce “droga”, nonostante in lui regni la consapevolezza che, praticando quella condotta, uccida per ben due volte la madre di “Aurora”, eludendone sacrifici e speranze, poiché fortemente desiderava un futuro migliore e “diverso” per sua figlia.
Da quell’ “ufficio” nel quale quotidianamente si reca, di ragazze che frettolosamente si apprestano a raggiungere l’università, “Aurora” ne incontra molteplici, eppure la droga le ha divorato sogni ed identità, in maniera così totalizzante e devastante da imporre a rimpianti ed emozioni, di qualsivoglia genere e natura, di affievolire silenziosamente.
Nella sua vita, ormai, c’è tempo e spazio solo per la droga.
“Aurora” ed il suo carnefice, condividono una sorta di appartamento, ubicato nelle poco distanti e famigerate “vele”, insieme ad altri tossici, con i quali spartiscono anche il bagno, oltre che il cibo e le dosi, allorquando qualcuno di loro non è stato capace di racimolare gli spiccioli necessari per accaparrarsene una tutta per sé.
“Aurora” non possiede nulla di “suo”: i soldi che raccatta a ridosso della metro, deve consegnarli al suo “compagno-patrigno-padrone” ed è lui che decide come “investirli”.
Nemmeno i vestiti che indossa sono “suoi”: lei ed i suoi coinquilini, condividono anche un’essenziale armadio che custodisce “gli abiti collettivi”.
“La droga mi ha tolto la voglia di dormire, di mangiare, di farmi bella…Mi ha tolto tutto. Quando diventi un tossico, desideri solo di farti”.
Mentre “Aurora” affonda lacrime e parole nella sua desolante storia, alle sue spalle troneggia un grosso palazzo, sul quale spicca una scritta: “BASTA CREDERCI E TROVI UN MARE DI BENE A SCAMPIA”.
“Scampia è “un’Italia in miniatura” in cui non sono riprodotti i monumenti più importanti, ma le problematiche più barbare e disumane che gravano sulla società. Il mare, qui, io non l’ho mai visto, neanche quando sono in preda allo “sballo”, dopo essermi iniettata una dose.”
Le chiedo qual è il saluto più consono del quale avvalersi per congedare “una come lei”, giacché le circostanze che imperversano nella sua vita, rendono logicamente impossibile indirizzarle un cordiale: “Arrivederci”.
Di lì a poco, potrebbe giungere “la sua dose esiziale” e, domani, tornando a Scampia, potrei non incontrarla più.
“E’ esattamente quello che le persone munite di buon senso devono augurare a noi tossici, quando li incontrano per strada: più presto giunge “l’ultima dose” e prima il nostro corpo termina di sottoporsi a queste angoscianti pene, perché siamo tutti morti che camminano. L’anima di un tossico vola via quando stringi tra le mani la prima siringa, ovvero, nel momento in cui preferisci la vita alla morte”.
Seppur non sia il suo nome reale, ho scelto di chiamarla “Aurora”, affinché la sua cruda ed agghiacciante testimonianza possa indurre “quelli come lei” ad uscire dal pesto buio che ne strozza le vite per spingersi alla ricerca della loro liberatoria “aurora”.