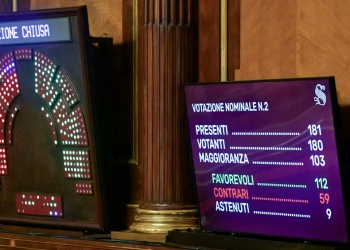Ai piedi del Vesuvio è risaputo che gli autobus amano farsi desiderare e l’attesa, spesso, si tramuta in un improvvisato momento di socializzazione.
Ai piedi del Vesuvio è risaputo che gli autobus amano farsi desiderare e l’attesa, spesso, si tramuta in un improvvisato momento di socializzazione.
Due adolescenti mi siedono accanto, vestite come tutte le teenager di oggi: pantaloncini, o meglio shorts, messa in piega studiata ad arte per valorizzare gli shatush, trucco marcato su occhi e bocca, accessori “giusti”, il basco, la collana con un vistoso ciondolo, gli anelli stravaganti, gli occhi pieni di sogni e la bocca che incespica in concetti precoci, una rapida chattata su Whatsapp con il ragazzino di turno, il dibattito che precede il verdetto sul da farsi, dopo che lui chiede: “Usciamo stasera? Vengo con un amico che ha già la patente, porta un’amica.”
“E l’amico!? Com’è? Se poi è brutto e a me non piace, che facciamo!?… Meglio di no, siamo state in giro tutto il giorno, sono stanca.”
Una foto scattata per smorzare i toni della delusione conseguente all’idea di dover dare buca ad un acerbo principe azzurro: “Siamo venute male, non pubblicarla su Facebook… Ma poi!??! Hai deciso!? Questo tatuaggio, lo fai o no?”
E in quel momento l’occhio cade sull’anulare sinistro della ragazza che gli siede accanto, giusto il tempo di scambiarsi dei fugaci e complici sguardi d’intesa ed una delle due avanza la fatidica domanda: “Scusa… Posso chiederti se fa male il tatuaggio sul dito? … Perché vorrei farlo… Però ho paura…”
Quel quesito che incartava il tintinnio che accompagna le più fragili ed ingenue paure è stato il pass che mi ha conferito libero accesso ad una delle stanze più affascinanti della nuova generazione.
Una delle due ragazze, in particolar modo, aveva un palpabile e viscerale bisogno di raccontare la sua storia. Non so quale fosse il suo nome, perché la sincera fame di interagire ci ha scaraventato oltre il mero e consueto copione che abitualmente le persone recitano nell’arco delle prime battute di una conoscenza, quella gracile bozza di donna, però, ha saputo lasciarmi un biglietto da visita di ben altra e più profonda natura.
Cresciuta fino all’età di 10 anni a Parma, per poi trovarsi traumaticamente trapiantata in una delle periferie di Napoli più cupe e contaminate dal fragoroso abbandono, 15 anni, quarta di sei figli, madre casalinga, padre che “si spacca la schiena lavorando come operaio per guadagnare quello che a stento gli permette di crescere me e i miei fratelli, mentre i politici si mangiano i suoi sacrifici”, un diploma alberghiero da agguantare e il lavoro da cameriera che guarnisce il sabato sera, in maniera così stranamente inusuale e dissonante rispetto a quello dei suoi coetanei.
“Lavoro perché non voglio essere un ulteriore peso per i miei genitori. È massacrante, inizio alle 17 e finisco alle 3 di notte, la stanchezza te la porti dietro per tutta la settimana, ma so cosa significa fare i sacrifici e i miei genitori devono pensare principalmente ai miei fratelli più piccoli.”
No, non ero preparata a questo.
Fino all’istante prima di incrociare quell’umile germoglio di vita, in me regnava la ferma convinzione che questa fosse una generazione costituita da un esercito di bimbiminchia, incapaci d’intendere e pretenziosi nel volere.
Quella donna travestita da ragazzina, giunonica e candida rosa in un deserto arido di principi ed opportunità, come la realtà nella quale vive, invece, ha sfaldato le mie frettolose convinzioni con una genuina e disarmante semplicità.
“Ho scelto la scuola alberghiera perché amo la divisa, mi trasmette sicurezza e il mio sogno è di entrare nel corpo della Marina Militare”.
Allora l’amica interviene per confidare quello che quella riservata e timida modestia le impedisce di ribadire a voce alta: “Non è vero, il suo sogno è diventare una cantante… Ha una voce splendida e canta benissimo, è bravissima!”
Allora, lei nasconde l’imbarazzo dietro un pudibondo ed arrossito sorriso, abbassa lo sguardo e non appena lo rialza, replica: ”Si, è vero… Mi piace cantare, ma quelli sono i sogni che appartengono agli scansafatiche, per coltivare una passione come il canto occorrono soldi e tempo e io non ne ho….”
Allora, la nostra conversazione devia sulla musica, sui fenomeni da reality show e sugli ululati, fonati e lampadati, dei “nostri” neomelodici, mentre, intanto, l’autobus arriva e ci offre un improvvisato salotto in movimento nel quale continuare il nostro scambio di frammenti di vita, un pò come fanno i bambini con le figurine “ti cedo i miei doppioni, in cambio dei tuoi.”
Di “doppioni”, a fronte dei 15 anni di soggiorno in più trascorsi su questa terra, avrei dovuto cederne di più io, invece, quelle ragazze, avevano più voglia di sfogliare il mio album per scorgere l’aspetto di quelle figurine che ancora gli mancano, tant’è vero che l’emozione più nuda che hanno saputo donarmi, l’ho raccolta nella saggezza insita nell’assenza del “tutto e subito”, così rara da rilevare, non solo negli adolescenti, ma nella prevalente parte degli esseri umani.
Tante, tantissime domande, contaminate da quella romantica, sincera e sognatrice ingenuità alla quale troppo raramente si tributa forma e fiato, sul sesso, sull’amore, sul “diventare grandi”, sulle responsabilità.
Avevo davanti a me delle enormi tele bianche e ho scelto di accennare delle bozze, delicatamente, a matita, per consentire a quelle anime incontaminate dalla delusione e dalle angherie del mondo, di scegliere, quando saranno in grado di ascoltare la voce che soffierà dentro di loro, con quali colori e trame gremirle.
Poco prima di giungere alla mia fermata e congedare le mie inaspettate compagne di viaggio, sono stata sopraffatta dalla curiosità di conoscere “il volto” del fulcro che ha azionato quel motore di genuina e reciproca scambievolezza, ovvero, quale fosse il disegno che quella ragazza era intenzionata a tatuarsi.
“Una piccola chiave di violino che racchiuda una “F”… Perché la musica è il mio sogno impossibile e la “F” è l’iniziale del nome di mia nonna… È venuta a mancare pochi mesi fa… Lei diceva sempre che si vive di speranza e lei ha vissuto tutta la vita aggrappata alla speranza… Quel tatuaggio è il mio modo di ricordare a me stessa che non è importante se riesci a realizzare o meno i tuoi sogni, ma devi sempre continuare a sperare che succeda.”
Ieri, per la prima volta, ho ricevuto una sonora lezione di vita da una “donna” anagraficamente “più piccola” di me, ma umanamente e mentalmente “più grande” di tante altre sterili anime nelle quali mi sono imbattuta, non altrettanto meritevoli di essere annoverate come “donne”, solo perché l’anagrafe imporrebbe che lo fossero.
Ascoltiamo i nostri ragazzi, senza fermarci a quello che farfugliano le loro sconce capigliature e i pantaloni penzolanti per impacchettare avventate conclusioni sulle quali affrancare altrettanto grossolane ed opinabili etichette.
“Sentiamo” quello che hanno da dire, perché le loro “odi moderne” rischiano di stupirci ed arricchirci.