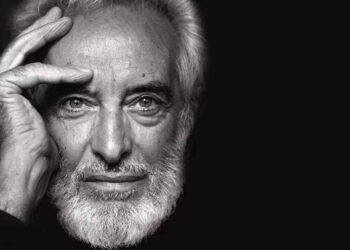Passeggiare tra i Quartieri Spagnoli, vuol dire calpestare i frammenti più sinceri e roventi della propria napoletanità.
Passeggiare tra i Quartieri Spagnoli, vuol dire calpestare i frammenti più sinceri e roventi della propria napoletanità.
Quel contorto ed aggrovigliato labirinto di salite e discese, scalini e scalette, gradini e gradoni; fugaci schegge d’umanità in sella agli scooter; donne semplici nella loro articolata complessità, vistose, appariscenti, eppur così “nude”, nei modi di fare, nella spontanea generosità che instancabilmente porgono a chiunque incroci le loro ciabatte, macchiate di caffè e cortesia; uomini stanchi all’alba e ritemprati di notte; santi, ossequiati con un costumato lume, perennemente acceso; santi che non soggiornano distaccatamente ubicati su di un solenne piedistallo, ma, piuttosto “vivono” a ridosso della strada, quali spettatori tutt’altro che statici ed inermi, perché , in quella spessa e corposa fetta di Napoli, i loro occhi sono quelli degli unici “testimoni oculari” ai quali è lecitamente e rispettosamente concesso di vedere tutto, senza indossare quel comodo schermo protettivo rappresentato da “occhiali d’omertà” e le loro orecchie sono chiamate ad ascoltare qualsiasi gemito, sospiro, sussulto, preghiera, sfogo, accorata e disperata richiesta, timori, ansie, preoccupazioni, angosce, palpiti, perfino bestemmie ed imprecazioni, generati dalla terra e dalle bocche.
Nei Quartieri Spagnoli, i santi vestono gli abiti più semplici ed umili, quelli utili a conferirgli le sommesse sembianze di “esseri umani”.
Il sentore che mi striscia addosso tutte le volte che mi addentro in quella finestra spalancata sulla più nuda indole di Napoli è che devo tenere gli occhi ben aperti per agguantare con destrezza quel fugace ed impercettibile attimo in cui mi consentirà di scorgere un brandello della sua essenza, un po’ come fa una donna munita di un fulgido ed avvenente corpo, giocando con la sensuale sottana di raso che succintamente lo copre, tirandola su di qualche centimetro per lasciare a corto di fiato, quegli occhi che sa che la stanno spiando attraverso il buco della serratura.
Allora, alzando gli occhi verso il cielo, la mia attenzione è stata catturata da una di quelle chilometriche corde forgiate a stenditoio, che si diramano da un balcone all’altro, di balcone in balcone, creando quel variegato, casuale, eppur ineccepibilmente perfetto, gioco di proporzioni e colori.
Quella semplice, ma peculiare corda che, di per se, già personifica l’ingegnosa e pragmatica arte d’arrangiarsi, sagacemente miscelata al sangue di questo popolo.
In quel caso, la corda si gremiva di abiti neri, che davano luogo ad un toccante moto, malinconico ed armonico, mentre si susseguivano, uno dietro l’altro, come i vagoni di un funereo treno.
Una maglia nera, un pantalone nero, una gonna nera, un golfino nero.
Nero.
Ancora nero.
Tutto nero.
I miei occhi devono aver involontariamente disegnato nell’aria le traiettorie che la mia mente stava percorrendo, se, chi mi era accanto, ha sentito il dovere di raccontarmi che le mani che stendevano al sole quei ferali abiti appartenevano ad una donna rimasta sola, disperatamente e rabbiosamente sola.
Marito definitivamente messo al tappeto da ripetuti e ferini colpi di pistola, durante un agguato camorristico.
Il primo figlio lo ha avvelenato la droga.
Il secondo ha terminato la sua ultima corsa contro la criminalità schiantandosi contro un muro con lo scooter, mentre tentava di fuggire, dopo aver compiuto una rapina a mano armata in una gioielleria.
Il terzo ha scelto la soluzione più agghiacciante per ribellarsi a quell’inevitabile destino che segnava con tratti severi e marcati la sua strada: si è tolto la vita impiccandosi nel bagno del carcere nel quale stava scontando la pena. Spaccio di sostanze stupefacenti: il reato che gli ha fornito il pass per quell’infausta vacanza.
Spacciatore e tossicomane ed aveva appena 20 anni.
Non sopportava più le crisi d’astinenza e forse anche il peso di tutto quel marcio che come il più impietoso dei macigni, gli opprimeva serenità e futuro, con turpe, insopportabile e straziante brutalità.
Fino al punto di svilire, affossare e digradare l’amore di una madre, l’amore per una madre.
Il primo, il più sacro ed autentico dei sentimenti che ci viene radicato in petto.
Fino al punto di strapparsi dal cuore quel primordiale sentimento e dare irreversibilmente in prestito muscoli e fiato a quell’estremo e disperato gesto, dal quale non si torna più indietro e che impone, anche e soprattutto, di lasciare sola quella madre.
Sola con il suo dolore, sola a combattere contro quello straziante e nefando mostro di repulsiva, malvagia e belluina ingiustizia.
Ingiustizia figlia illegittima della precarietà, di quella sottile, tutt’altro che scontata ed, al contempo, sistematicamente scontata, condanna che si appiccica addosso ad un neonato che vede la luce lì, proprio lì; figliastra dell’ignoranza che si arrampica alle pareti della svogliata cialtroneria, che radica quei bambini in contesti che di fanciullesco e spensierato non hanno neanche il pallone che prendono a calci, ma che, piuttosto, si rivela lesta nel plasmarli in uomini prematuri, catapultati in un mondo troppo spietato, saturo di paradossi, angherie, trappole e difficoltà.
Quella donna, da quando è rimasta sola, trascorre tutte le sue giornate e gran parte della sua giornata, a lavare i suoi abiti.
Detergendoli con l’ammorbidente e l’utopica speranza di ripulirli dal lutto e da quella grassosa e corpulenta macchia di dolore, mossa dall’inafferrabile brama di vederli, almeno una volta, splendere, candidi ed immacolati, alla luce del sole.
In quegli abiti, distesi al sole e protesi verso il sole, ho scorto il nudo e feroce desiderio di rivalsa che arde nel petto di quella benevola ed instancabile madre che si chiama “Napoli”.