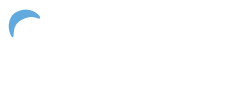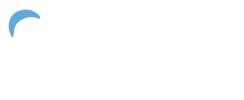Il 3 settembre 1982 rappresenta una delle pagine più drammatiche e significative nella storia della lotta alla mafia in Italia.
Quella sera, il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, prefetto di Palermo, e sua moglie Emanuela Setti Carraro furono brutalmente assassinati mentre si dirigevano verso un ristorante a bordo della loro A112 bianca, seguiti dall’agente di scorta Domenico Russo, alla guida di un’Alfetta.
Intorno alle 21:15, lungo via Carini, la loro auto venne affiancata da una BMW e da una motocicletta da cui partirono raffiche di kalashnikov AK-47, che uccisero immediatamente i due coniugi e l’agente di scorta. Un atto di violenza inaudita che scosse profondamente l’Italia e il mondo intero.
Dalla Chiesa non era un prefetto qualsiasi. Con i suoi metodi investigativi innovativi e la determinazione instancabile, aveva inflitto colpi durissimi sia a Cosa Nostra sia alle Brigate Rosse in Piemonte. Grazie a lui furono portati alla luce collegamenti fino ad allora insospettati tra la criminalità organizzata, la politica e una parte delle istituzioni.
Personaggi chiave della mafia come Tommaso Buscetta e Michele Greco, fino ad allora sconosciuti agli investigatori, entrarono così nell’obiettivo della giustizia, aprendo la strada a indagini che avrebbero cambiato il volto della lotta alla criminalità organizzata in Italia.
Negli ultimi tempi, però, il generale Dalla Chiesa si era sentito abbandonato dalle istituzioni centrali. In un’intervista rilasciata a Giorgio Bocca per il quotidiano la Repubblica, denunciava la scarsità di mezzi e risorse a sua disposizione, consapevole del pericolo crescente a cui era esposto nella sua missione.
Le indagini sulla strage di via Carini furono complesse e serrate. Dopo anni di lavoro investigativo e processuale, il tribunale condannò come mandanti sei dei boss più potenti di Cosa Nostra: Totò Riina, Bernardo Provenzano, Michele Greco, Pippo Calò, Bernardo Brusca e Nenè Geraci, insieme a quattro esecutori materiali.
La morte del generale Dalla Chiesa rappresenta non solo la perdita di un grande servitore dello Stato, ma anche un monito drammatico sulla pericolosità e l’influenza della mafia in Italia. La sua eredità rimane viva nella memoria collettiva, nei metodi di indagine che ha introdotto e nel coraggio con cui ha sfidato il crimine organizzato.