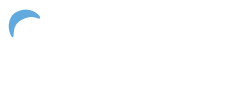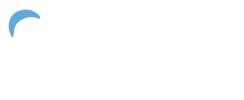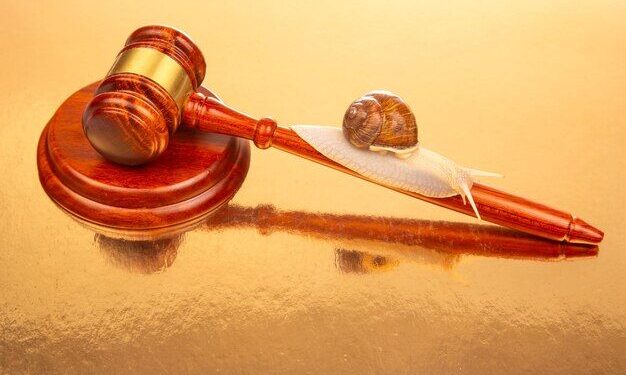Il recente scandalo delle scarcerazioni nel maxi-processo al clan Moccia, dove anche imputati di alto profilo criminale sono tornati liberi per decorrenza dei termini di custodia cautelare, non è solo un episodio isolato. È il simbolo clamoroso di un sistema giudiziario che fatica a reggere il peso dei propri ritardi, lasciando che la lentezza diventi alleata dell’impunità.
Nel cuore della vicenda, infatti, non c’è una sentenza di assoluzione, ma l’incapacità dello Stato di garantire un processo entro tempi ragionevoli. E questo, in un procedimento contro uno dei più potenti clan della camorra, rende tutto ancora più grave. Si tratta di una resa istituzionale, che mina la credibilità della giustizia e affievolisce la fiducia dei cittadini nella legalità.
Secondo i dati della Commissione Europea per l’Efficienza della Giustizia (CEPEJ), l’Italia detiene il poco invidiabile primato della durata media dei processi penali più lunga d’Europa: oltre 1.167 giorni in appello – più di tre anni – contro una media europea di 121 giorni. Nel 2024, la durata media in primo grado era di circa 355 giorni, quasi il triplo rispetto alla media UE (133 giorni), e in appello oltre 750 giorni (contro i 110 europei).
Le conseguenze di questi ritardi si misurano anche nei numeri spietati della prescrizione: circa il 24–25% dei procedimenti penali si estingue prima di arrivare a sentenza. Di questi, oltre il 65–70% si spegne già nella fase delle indagini preliminari, senza neppure un confronto in aula tra accusa e difesa. Un’enormità che rischia di trasformare il principio di “giusto processo” in una formula vuota, incapace di garantire né giustizia per le vittime, né certezza del diritto.
Alla base di questo collasso ci sono fattori strutturali. L’Italia conta meno di 12 magistrati ogni 100.000 abitanti, contro una media europea di oltre 22. Il personale amministrativo è carente, la mole di fascicoli ingestibile, e la digitalizzazione della macchina giudiziaria, prevista dalla riforma Cartabia e dal progetto dell'”Ufficio per il Processo”, è ancora ben lontana dall’essere pienamente operativa.
Molte cancellerie non dispongono di infrastrutture informatiche adeguate, i software sono spesso instabili, e la gestione elettronica degli atti resta farraginosa. Un paradosso in un’epoca in cui l’efficienza digitale è la base di qualsiasi sistema moderno.
Non sorprende allora che l‘Italia sia ai primi posti per sanzioni della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo per l’eccessiva durata dei processi. Dal 1959, l’Italia ha collezionato 1.230 violazioni, più del doppio rispetto alla Turchia. Un dato che fa riflettere sulla portata sistemica del problema.
Nel caso del clan Moccia, la giustizia ha mancato il suo obiettivo più elementare: portare i colpevoli (o presunti tali) a processo in tempi ragionevoli. Il rilascio di soggetti ritenuti pericolosi non è avvenuto per mancanza di prove, ma per l’eccessiva durata della custodia cautelare non accompagnata da una sentenza. Questo non è solo un fallimento tecnico, ma un colpo alla legittimità stessa dello Stato di diritto.
Una giustizia così lenta non è semplicemente inefficiente. È ingiusta, perché nega il diritto alla verità e alla tutela, aliena i cittadini e indebolisce l’intero impianto democratico. Lascia liberi troppi protagonisti di reati gravi, compromette il lavoro delle forze dell’ordine e colpisce soprattutto chi nella giustizia crede ancora.