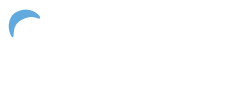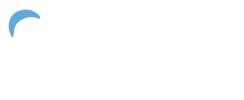L’estate 2025 si conferma come una delle più cruente per il nostro Paese sul fronte incendi boschivi, alimentata da un’ondata di calore intensa e persistente che ha trasformato territori, ecosistemi e vite in un enorme rogo.
Dal 1° gennaio al 18 luglio 2025, in Italia sono stati registrati 653 incendi che hanno distrutto 30.988 ettari di territorio, pari a circa 43.400 campi da calcio. Di questi, 18.115 ettari erano aree naturali e boschive, 12.733 agricoli e 120 artificiali.
Le regioni del Sud e delle isole sono state le più colpite: Sicilia in testa con 16.938 ettari in 248 incendi, seguita da Calabria (3.633 ettari/178 eventi), Puglia (3.622 ettari/69), Basilicata (2.121 ettari/13 incendi, ma con media più alta per evento), Campania (1.826 ettari) e Sardegna (1.465 ettari).
L’Italia è stata colpita da un’ondata di calore straordinaria, con temperature superiori ai 40 °C in almeno 18 città e condizioni ambientali che hanno amplificato il rischio di roghi. Le autorità nazionali e regionali hanno diramato allerta rossa e varato provvedimenti urgenti per limitare i danni .
Nella giornata del 27 luglio, un vasto incendio in Sardegna meridionale, a Villasimius, ha imposto l’evacuazione urgente di decine di bagnanti: alcuni sono stati evacuati via mare dopo che fiamme e fumo avevano bloccato le vie terrestri. Diversi veicoli sono stati distrutti dalle fiamme, complicando le operazioni di evacuazione aerea e via terra, rallentate anche dai forti venti.
Nel complesso, la giornata ha visto decine di roghi attivi in diverse zone della Sardegna, alimentati dall’ondata di caldo africano che continua a colpire il Mediterraneo.
Il 26 giugno sono stati registrati 14 incendi, di cui 8 hanno richiesto l’intervento di Canadair ed elicotteri, con operazioni coordinate tra Corpo forestale e vigili del fuoco .
Il 16 giugno, in una sola giornata, la regione ha affrontato oltre 40 incendi, con l’utilizzo massiccio di squadre a terra e mezzi aerei, in particolare nella zona di Furtei e Bonorva.
Le località più colpite includono Furtei, Bonorva, Segariu, e Bruncu Sturrui nell’area tra Sinnai e Burcei, dove è stato impiegato anche l’elicottero Drago della flotta antincendio.
Gli esperti attribuiscono la veloce propagazione dei roghi a venti forti – in particolare il maestrale – e temperature estreme che mantengono il territorio secco e infiammabile. Dietro molti focolai sembra esserci la mano dolosa dei piromani, in un contesto in cui gli incendi stagionali restano frequenti ogni estate.
Dal 2021, in regioni come il Montiferru in Oristano, oltre 20.000 ettari di boschi e pascoli sono stati distrutti, causando effetti irreversibili sul patrimonio naturale e agricolo .
Le operazioni di spegnimento vedono impegnati Corpo forestale, Forestas, vigili del fuoco, barracelli, volontari della protezione civile, con l’ausilio strategico di mezzi aerei nazionali e regionali .
In località come Genna Lada ad Arbus, le fiamme sono state domate grazie all’intervento combinato di elicotteri e pattuglie forestali; a Funtana e’ Figu (Ardara), il rogo è stato spento in mattinata grazie anche alla base di Anela.
Secondo ISPRA e Greenpeace, circa il 40% degli incendi boschivi in Italia è doloso o causato da negligenza. A ciò si somma il cambiamento climatico, che incrementa temperatura e siccità favorendo roghi estesi e intensi. Per il 2025 si stima un aumento tra il 10 e il 15% delle aree in fumo rispetto al 2024.
Una denuncia riguarda anche l’assenza di una governance nazionale efficace. Secondo Legambiente, manca una cabina di regia integrata statale-regionale, con conseguenze nella prevenzione e nella risposta operativa.
In Campania, già dal 15 giugno sono in vigore divieti severi: stop ai fuochi nei boschi, abbruciamenti agricoli, uso di bracieri o fiamme vicino a pascoli, divieto di fuochi d’artificio e sigarette in zone boschive.
L’Italia sta affrontando una crisi ambientale strutturale: ogni giorno 3,3 incendi mediamente dal 1° gennaio, oltre 30mila ettari in fumo entro il 18 luglio, in un crescendo dovuto a caldo estremo, negligenza e aridità cronica. Il Sud e le isole sono le aree più colpite, con impatti gravissimi sugli ecosistemi e sull’economia locale.