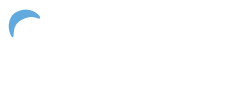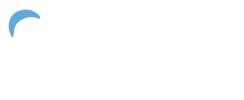La Liberazione dell’Italia dal nazifascismo, culminata il 25 aprile 1945, è uno degli eventi più significativi della storia italiana contemporanea. Questo momento epocale, che segnò la fine dell’occupazione nazista e del regime fascista, è stato raccontato con intensità e passione anche attraverso il cinema. Numerosi registi italiani hanno dedicato opere alla Resistenza, offrendo al pubblico una memoria collettiva potente e toccante.
Tra i primi a raccontare la Liberazione fu Roberto Rossellini con Roma città aperta (1945), film simbolo del neorealismo. Girato subito dopo la fine della guerra, narra le vicende di un gruppo di partigiani a Roma durante l’occupazione tedesca. La pellicola, con un’interpretazione intensa di Anna Magnani, è diventata un emblema del dolore e del coraggio del popolo italiano.
Anche Paisà (1946), sempre di Rossellini, racconta episodi della Liberazione attraverso sei storie ambientate lungo la penisola, mostrando l’incontro – spesso drammatico – tra gli italiani e le forze alleate.
Un altro titolo fondamentale è Una vita difficile (1961) di Dino Risi, con Alberto Sordi. Il film racconta la storia di un ex partigiano alle prese con le delusioni dell’Italia del dopoguerra, evidenziando il difficile rapporto tra gli ideali resistenziali e la realtà politica e sociale degli anni successivi.
Negli anni successivi, il cinema italiano ha continuato a riflettere sulla Resistenza, spesso adottando toni più critici o intimisti. Il partigiano Johnny (2000), tratto dal romanzo di Beppe Fenoglio e diretto da Guido Chiesa, offre uno sguardo introspettivo sulla figura del combattente, lontano dalla retorica e vicino alla dimensione umana e tragica della guerra civile italiana.
Altri film, come La notte di San Lorenzo (1982) dei fratelli Taviani, mescolano storia e leggenda, raccontando la fuga di un gruppo di civili da un villaggio toscano per sfuggire ai tedeschi. Il film è poetico e visionario, e mostra come la memoria popolare possa intrecciarsi con la grande storia.
Anche in tempi più recenti, il tema della Liberazione continua a ispirare il cinema. Film come L’uomo che verrà (2009) di Giorgio Diritti, ambientato durante l’eccidio di Marzabotto, mostrano il dramma dei civili in un contesto di violenza estrema. La narrazione si fa più intima, mettendo al centro le vittime innocenti e lo sguardo dei più fragili. La vicenda è raccontata dal punto di vista di una bambina muta, simbolo della fragilità dell’innocenza di fronte all’orrore.
I piccoli maestri (1998) di Daniele Luchetti, tratto dal romanzo autobiografico di Luigi Meneghello, racconta la formazione politica e umana di un gruppo di giovani studenti universitari che scelgono di unirsi alla Resistenza, evidenziando il coraggio e i dubbi di chi decise di combattere.
Un altro film da ricordare è Corbari (1970) di Valentino Orsini, ispirato alla vera storia del partigiano Silvio Corbari, eroe romagnolo della Resistenza. La pellicola sottolinea la drammaticità e il sacrificio di molti giovani durante gli ultimi anni del conflitto.
I film sulla Liberazione sono fondamentali non solo per ricordare, ma anche per comprendere le radici della Repubblica italiana. Attraverso il cinema, la Resistenza non è solo storia, ma racconto condiviso, emozione e impegno civile. In un’epoca in cui la memoria rischia di affievolirsi, queste opere restano un faro acceso sulla strada della libertà e della democrazia.