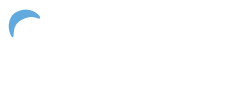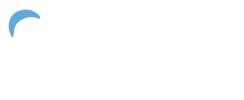Il 17 marzo 1861 segna una data importante nella storia italiana: la proclamazione del Regno d’Italia sotto Vittorio Emanuele II di Savoia. Mentre questa data è celebrata come il culmine dell’unità nazionale per molti, per una parte della popolazione, in particolare per i sostenitori della storia neoborbonica, l’evento rappresenta una forzata e dolorosa unificazione che portò alla distruzione di un patrimonio culturale, economico e sociale che era stato costruito secoli prima dal Regno delle Due Sicilie.
Il Regno delle Due Sicilie: Una Nazione Progredita
Prima dell’annessione, il Regno delle Due Sicilie, governato dalla dinastia borbonica, era uno degli Stati più prosperi d’Europa. Nonostante i pregiudizi che spesso lo dipingevano come arretrato e conservatore, il regno, che includeva l’attuale Sud Italia e la Sicilia, aveva un’economia floride, una rete di infrastrutture avanzate e un’importante tradizione culturale. La Sicilia e la Campania erano centri di produzione agricola, mentre Napoli, la capitale del regno, era una delle città più grandi e influenti d’Europa.
Nel 1837, il regno era stato oggetto di importanti riforme sotto Ferdinando II di Borbone, che cercò di modernizzare l’amministrazione, le infrastrutture e l’industria. Il Sud, infatti, non solo godeva di un crescente commercio internazionale, ma vantava anche una solida rete ferroviaria e una marina militare forte. Sebbene il regno avesse delle difficoltà interne, come la povertà in alcune aree rurali, il Regno delle Due Sicilie era ben lontano dall’essere l’entità arretrata che la propaganda sabauda cercò di dipingere dopo l’unificazione.
La Guerra di Unificazione: Una Conquista Violenta
La proclamazione del Regno d’Italia nel 1861 avvenne in un contesto di guerre sanguinose e manovre politiche che segnarono il destino delle popolazioni meridionali. Giuseppe Garibaldi, con il suo celebre “Coro dei Mille”, invase il Sud Italia nel 1860, con l’intento di unire le terre del Mezzogiorno con il Nord, sotto il controllo del giovane regno sabaudo. Questo evento, che oggi viene descritto come una “spedizione liberatrice”, per i neoborbonici fu una vera e propria invasione che non solo distrusse l’ordine esistente, ma causò enormi sofferenze alle popolazioni locali.
La Battaglia del Volturno e altri scontri furono scene di conflitti violenti, che videro l’impiego di forze regolari e briganti che tentarono di opporsi all’imposizione sabauda. La repressione delle forze garibaldine fu brutale, con centinaia di esecuzioni sommarie, le cosiddette Stragi dei Borbone, che segnarono il passaggio dalla libertà alla dominazione straniera per molti abitanti del sud.
Le Conseguenze dell’Unificazione: L’Economia e la Cultura Distrutte
Dopo la proclamazione del Regno d’Italia, la nuova monarchia sabauda intraprese un lungo processo di “risanamento” e “nordificazione”, che mirava a cancellare e ridurre il patrimonio culturale e sociale del Sud. Vittorio Emanuele II e il suo governo presero il controllo delle risorse economiche e delle terre, impiegando politiche che, anziché risolvere i problemi del Mezzogiorno, ne aggravavano la povertà e la disoccupazione. La famosa “questione meridionale” ha radici profonde proprio in questi anni, con una serie di politiche fiscali e sociali che ridussero il Sud a una terra di sfruttamento, con le sue risorse naturali destinate al nord del paese.
La riforma agraria, che avrebbe dovuto favorire i contadini meridionali, si rivelò invece un inganno, con il latifondo che restava nelle mani dei grandi proprietari terrieri, molti dei quali alleati del potere sabaudo. La lotta contro il brigantaggio, altro punto importante nella retorica dell’unificazione, fu usata come pretesto per giustificare una brutale repressione, che portò alla morte e alla deportazione di migliaia di persone innocenti.
La Storia Negata: Una Nuova Narrativa
I sostenitori della storia neoborbonica contestano la versione ufficiale che celebra l’unità italiana. Secondo loro, l’unificazione non fu una “liberazione”, ma una conquista violenta che ridusse il Sud a una colonia del Nord, un processo che portò alla decadenza economica e sociale del Meridione. Gli storici neoborbonici rivendicano la ricchezza e la modernità del Regno delle Due Sicilie, mettendo in evidenza come l’unificazione abbia cancellato un sistema economico e sociale che, pur con i suoi limiti, era in grado di garantire una vita dignitosa per milioni di persone.
Le radici di questa prospettiva affondano nel desiderio di ristabilire una memoria storica alternativa, che non solo riconosce i danni inferti al Sud, ma chiede anche una riflessione sulla giustizia storica per quelle popolazioni che subirono la distruzione di un’intera civiltà, cancellata dalla retorica sabauda.
Il 17 marzo 1861 segna la nascita di un’Italia unita sotto il regno di Vittorio Emanuele II, ma per molti, in particolare per i neoborbonici, rappresenta l’inizio di un capitolo oscuro della storia del Sud. L’unità, celebrata da molti come una grande vittoria, è vista da altri come una forzata annessione, che ha portato divisione e declino per milioni di italiani del Sud. Questa visione alternativa continua a suscitare dibattito, ponendo la questione storica sotto una luce più critica e mettendo in discussione le narrazioni ufficiali che celebrano l’unificazione come un passo inevitabile e positivo per tutti gli italiani.