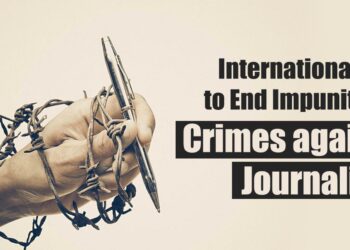Per il boss di Ponticelli Marco De Micco, all’alba di lunedì 4 aprile, si sono aperte nuovamente le porte del carcere.
Per il boss di Ponticelli Marco De Micco, all’alba di lunedì 4 aprile, si sono aperte nuovamente le porte del carcere.
Il fondatore e reggente dell’omonimo clan attualmente egemone a Ponticelli, era tornato in libertà a marzo del 2021.
“Bodo” – questo il soprannome di Marco De Micco – nel corso dei 380 giorni trascorsi a piede libero, ha attirato l’attenzione degli inquirenti mettendo la firma su azioni eclatanti, efferate, brutali, ciniche. Mirate a conquistare e preservare il capillare controllo del territorio.
Le indagini della Squadra Mobile di Napoli, coordinate dalla DDA partenopea, hanno ricostruito meticolosamente la macchina di morte innescata dal boss Marco De Micco per uccidere il 23enne Carmine D’Onofrio, indicato come l’artefice dell’ esplosione dell’ordigno artigianale avvenuta a settembre del 2021 in via Piscettaro, nei pressi dell’abitazione del nuovo leader maximo di Ponticelli.
Oltre a Marco De Micco, sono stati raggiunti dallo stesso provvedimento: Salvatore Alfuso, Giovanni Palumbo, Ciro Ricci, Giuseppe Russo, Ferdinando Viscovo e Maddalena Cadavero, la madre di De Micco.
Nomi che alle persone che vivono lontano da Ponticelli non dicono nulla e che invece tra le strade del quartiere hanno suscitato non poco scalpore.
Nomi che raccontano storie di giovani meglio conosciuti come “il piccione”, “il barbiere”.
Nomi, soprannomi che raccontano storie di vite bruciate dalla camorra.
“Il barbiere” ha sempre lavorato nel suo salone ed è conosciuto come un giovane “pulito”, appartenente ad una famiglia severa, per giunta, tra i cui ranghi si annoverano anche appartenenti alle forze dell’ordine. Suo padre, in passato, si è violentemente opposto alla sua relazione con la figlia di un “pezzo da 90” della malavita locale e lo ha picchiato selvaggiamente, pur di indurlo a metter fine a quel legame sentimentale. In tanti si chiedono come sia potuto accadere che proprio lui, il barbiere, figuri nello stesso blitz che ha fatto scattare le manette per il boss del quartiere.
“Il piccione” è uno dei tanti giovani che vivono ai margini del mito di Antonio “XX” De Martino, nel fortino dell’omonimo clan, il Rione Fiat. Lavorava in un supermercato, almeno fino a poco tempo fa. Lo hanno arrestato in una casa modesta, composta da due stanze, in una condizione fortemente in contrasto con gli sfarzi e la ricchezza che marcano le vite dei leader di quel clan che ha concorso a sancire come tali, macchiandosi pesantemente la fedina penale.
Un marchio destinato a segnare le vite di due ragazzi perduti come tanti, troppi giovani nei quali è fin troppo facile imbattersi in un contesto come Ponticelli.
Due giovani notoriamente estranei alle dinamiche camorristiche e che adesso si trovano in carcere, gravemente indiziati di aver partecipato all’omicidio di un coetaneo: Carmine D’Onofrio, ucciso pochi giorni prima di diventare padre, sotto gli occhi attoniti della sua compagna incinta, a due passi dall’abitazione della madre.
Un giovane incensurato, cresciuto coltivando la passione per il calcio e il teatro, nell’ignara consapevolezza di essere il figlio di Giuseppe De Luca Bossa, fratello del sanguinario killer ergastolano Tonino ‘o sicco. Una scoperta avvenuta pochi anni fa e che ha sancito la sua condanna a morte. Carmine ha voluto allacciare i rapporti con quel padre, tornato a Ponticelli dopo un lungo periodo in cui si era trasferito nel casertano per ereditare le redini del clan di famiglia e ricoprire il ruolo di boss in attesa della scarcerazione di suo nipote Umberto, primogenito di Antonio De Luca Bossa.
E’ così che Carmine entra in contatto con i cugini, i figli di quel temuto killer di Ponticelli il cui nome incute ancora timore, quando risuona tra i rioni in odore di camorra, malgrado sia recluso da decenni al 41 bis.
Seppure gli inquirenti non dispongano di prove concrete che inchiodino D’Onofrio come l’esecutore materiale del raid indirizzato a Marco De Micco, il nome del giovane è stato fin da subito associato a quell’evento con convinta insistenza all’indomani dell’agguato in cui venne barbaramente trucidato.
“I responsabili della comunicazione” del clan De Micco, nei giorni successivi all’omicidio di Carmine D’Onofrio, gettarono in pasto alle voci di popolo una ricostruzione montata ad arte, secondo la quale le prove del coinvolgimento del figlio di Peppino De Luca Bossa erano state fornite spontaneamente al boss da alcuni esercenti della zona che gli avevano consegnato le immagini dei sistemi di videosorveglianza. Appresa la notizia, il complice del 23enne, si sarebbe recato a casa del boss per negoziare la sua vita in cambio di quella della persona che lo aveva affiancato nell’esecuzione del raid. Sarebbe stato, quindi, il complice di D’Onofrio a fare il suo nome a Marco De Micco.
Come sovente accade in queste circostanze, le indagini hanno confermato che si trattava di una ricostruzione parziale dei fatti che hanno concorso a decretare la morte del 23enne. Una ricostruzione principalmente finalizzata ad alleggerire le responsabilità di colpa del boss e al contempo ringalluzzirne le quotazioni, mirando a fornire all’opinione pubblica un’immagine di lui sempre più temibile e temuta, sia dalla gente comune che dai rivali.
In realtà, un giovane contiguo al clan De Luca Bossa, Giovanni Mignano, è stato sequestrato, interrogato e malmenato dai De Micco per estorcergli il nome dell’attentatore. E’ stato lui a fare il nome di Carmine D’Onofrio.
Classe 1994, aveva solo 8 anni quando suo padre, Giuseppe Mignano detto “Peppe scè scè”, anche lui affiliato al clan De Luca Bossa, fu ucciso per volere del clan Sarno.
Eppure, anche lui, era riuscito a tenersi lontano dalla malavita. Lavorava in una paninoteca per 150 a settimana. Seppure avesse insistentemente manifestato la volontà di affiliarsi, per volere di un vecchio uomo d’onore del quartiere, quella possibilità gli è sempre stata negata.
Poi, l’incontro che gli ha cambiato la vita, quello con Umberto De Luca Bossa. Tornato in libertà e bisognoso di reclutare manovalanza per rinfoltire il clan, il primogenito di ‘o sicco ha trascinato nella mischia molti giovani come Mignano. Forse proprio per quell’indole debole e tutt’altro che confacente allo status di camorrista, “i Bodo” lo hanno irretito per ottenere quell’informazione necessaria per chiudere la partita con i rivali e sancire la fine delle ostilità.
Un blitz che ricostruisce una triste e fitta trama di storie di giovani vite spezzate dalla camorra.
Qualcuno è morto ucciso, come Carmine D’Onofrio.
Altri sono destinati a trascorrere nel peggiore dei modi quelli che dovrebbero essere gli anni migliori delle loro vite.
Dietro quei nomi, s’intravede la cinica regia di camorristi veri. Nomi pesanti che con cognizione di causa pianificano azioni e strategie malavitose.
Marco De Micco detto Bodo, il cui forte ascendente sulle giovani leve è storia nota, ma anche Salvatore Alfuso, 46enne dalla fama solida ed autorevole, seppure notoriamente ben più addentrato nella realtà camorristica del confinante comune di Volla e stimato essere elemento di spicco del clan Veneruso-Rea.