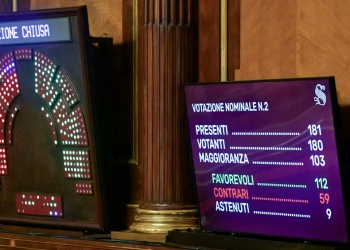In merito a quella complessa e paradossale faccenda che impazza tra gli spalti della maggior parte degli stadi italiani e che prende il nome di “discriminazione territoriale” sono state asserite ed azzardate tante, forse troppe considerazioni, teorie, freddure agghiaccianti, condite da satira incapace di innescare sorrisi, ma altresì più avvezza a liquefarsi in benzina, utile ad alimentare quel fuoco di polemiche, parole, paroloni, eccessi, intemperanze e ancora parole, portatrici insane di falsi e falsati messaggi solidali, come si conviene al cospetto di qualsivoglia “piaga sociale” che si rispetti.
In merito a quella complessa e paradossale faccenda che impazza tra gli spalti della maggior parte degli stadi italiani e che prende il nome di “discriminazione territoriale” sono state asserite ed azzardate tante, forse troppe considerazioni, teorie, freddure agghiaccianti, condite da satira incapace di innescare sorrisi, ma altresì più avvezza a liquefarsi in benzina, utile ad alimentare quel fuoco di polemiche, parole, paroloni, eccessi, intemperanze e ancora parole, portatrici insane di falsi e falsati messaggi solidali, come si conviene al cospetto di qualsivoglia “piaga sociale” che si rispetti.
Eppure, quella stessa definizione, che scaturisce dall’accostamento di due parole, due semplici parole, prima di ogni altra intenzione o teoria partorita da un branco di più o meno eccelsi neuroni, si rivela inabile a contenere e sorreggere il massiccio calibro di responsabilità insito nella sua stessa accezione di senso.
Quel disagio, figlio di una palese “incapacità”, risulta facilmente rilevabile agli occhi partenopei, abili, prima di altri, come sovente accade ed è già accaduto nella storia, nel carpire, sentire, rilevare, estrapolare e fare proprie, esperienze portatrici di insegnamenti, a loro volta, precursori di cambiamenti, sensazioni e percezioni da forgiare in “qualcosa di nuovo”.
La “discriminazione” di per se rappresenta, senza dubbio, la più agghiacciante forma di ripudio delle più basilari ed “umane” regole di viver civile che dovrebbero, incondizionatamente, monitorare la condotta di ogni “essere umano”.
Quei sentimenti “umani” che facilmente sappiamo riporre in una ciotola, insieme a del cibo, da collocare ai margini di una strada, al cospetto di un cane randagio che, in quanto tale, merita pena e commiserazione, seppure, proprio perché randagio, potrebbe, senza alcun preavviso, sferzare sfuriate brute e ferine.
Invece no.
Lo spirito caritatevole che muove le mani e le coscienze, in quei casi, rende legittimo e spontaneo un atto di ordinaria generosità che, paradossalmente, ci riveliamo, però, incapaci di estendere ai nostri stessi simili.
Preferiamo, infatti, vomitare taniche di odio ed intolleranza verso altri “esseri umani” che, in quanto tali, dovremmo percepire meritevoli di un atto d’amore o quantomeno, se risulta difficile rispecchiarsi negli occhi del “diverso” alla ricerca di un tassello di affinità, l’istinto di appartenenza alla “categoria umana”, dovrebbe tuttalpiù guidarci verso la combustione di quei sentimenti avversi ed ostili nei barili dell’indifferenza.
Il fallace e madornale errore che gronda dal vocabolo “territoriale”, invece, va rilevato, nell’approssimativa superficialità di voler delimitare un “confine” a qualcosa che per natura è “infinito”.
Perché Napoli non è una città, ma uno stato d’animo, un sentimento, un’icona.
Il napoletano non è un dialetto, ma una lingua.
La napoletanità non è uno status sociale o un tassello circoscritto ad una regione o una porzione geografica più o meno estesa, ma un profumo che inebria le narici di tutto il mondo; è la canzone più famosa, quella tradotta in tutte le lingue, quella che fa sorridere ed emozionare, più di ogni altra; è il dipinto più peculiare e riprodotto, oltre che il più disarmante e rinomato, dotato di un perenne moto armonico e di sconfinata ed incondizionata luce riflessa; è la tradizione, la storia, la maschera, la mimica, facciale ed emotiva, più rappresentativa dell’essenza pulita e sincera dell’umanità tutta; è la voglia di vivere propria dei raggi di sole che tutte le mattine accarezza il cuscino, proiettando su di esso, la nascita di un nuovo giorno.
Napoli è uno stile di vita, una corrente di pensiero, è l’arte del “non fare prima quello che puoi fare dopo” che si traduce in un risoluto “o’ facc’ quann’ tengo genio” e “prendiamoci un caffè“, a qualsiasi ora del giorno e della notte, personifica l’emblema della sincera e disinteressata voglia di volersi bene, perché offrire un buon caffè è l’atto di spontanea cortesia più amorevole che un persona può indirizzare ad un’altra persona.
Il napoletano è furbo e scaltro, ma ciò non equivale ad asserire che è “un ladro”.
Il napoletano è ingegnoso ed operoso, ma ciò non equivale a dire che è “un truffatore”.
Non tutti i “follower di Maometto” si lasciano esplodere, diversamente dovremmo fuggire a gambe levate ogni volta che ne incontriamo uno, analogamente, non tutti i napoletani portano in tasca una pistola e nell’anima cattive intenzioni.
La realtà asserisce che tante e tante volte, un napoletano qualunque, nell’arte, nella musica, nello sport, nel cinema e in infiniti e disparati altri ambiti è stato capace di scagliare una pietra contro quei muri alteri ed austeri di pregiudizi, generando una crepa, attraverso la quale poteva e può essere facilmente visibile quello spiraglio di verità che incarna il verace e schietto volto di questa città, della sua gente e della sua anima.
I napoletani non sono solo quelli che nascono, crescono e vivono a Napoli.
E sbaglia chi crede che “per capire Napoli, si deve nascere a Napoli”.
Non è un certificato di nascita o di residenza a sancire lo spirito d’appartenenza e ad imprimere in petto l’incondizionato amore per questa terra, lo dimostrano, in maniera chiara e marcata, coloro che, dopo essersi lasciati il Vesuvio alle spalle, rinnegano le loro origini, pur di scrollarsi dalla coscienza quell’onerosa eredità, complessa e difficile da amministrare, insita nell’ “essere napoletani”.
Di contro, nei secoli, la tortuosa e fascinosa storia di questa terra ha annoverato “figli adottivi” procreati da un utero diverso da quello di Parthenope ed allattati da altre mammelle, eppur altrettanto capaci di nutrirli con quella stessa linfa, unica ed essenziale, condizione indispensabile e tutt’altro che sufficiente per comprendere l’anima di questo popolo ed entrarvi in empatia.
Eppure, i cuori che sono riusciti nel suddetto intento e che, tuttora si scoprono capaci di intrecciarsi alle radici partenopee, avvelenate, ma tutt’altro che marce, azzurre, non perché contaminate da scorie e diossina, ma “contagiate”, prima di tutto e in maniera assai più incisiva, dal colore della sua anima, si scoprono, ancora, sempre e sistematicamente, impossibilitati a strapparsi Napoli dal petto.
Capire Napoli non vuol dire camminare tra le strade del centro storico, sorseggiare un buon caffè, gustare una pizza, fotografare i monumenti, lasciarsi accarezzare il viso e i capelli dal mare, dal sole, né tantomeno “sporcarsi le scarpe” spingendosi nei meandri “difficili” della periferia o dei quartieri, dove il sole batte ad intermittenza, piuttosto significa imparare a lasciar guidare i propri passi dal moto armonico, tumultuoso, fascinoso, ma tutt’altro che malvagio che scuote l’anima di questa città.
Perché la nuda realtà dei fatti è soltanto una: Napoli è l’unica città al mondo, nella quale, qualunque cittadino del mondo, può sentirsi a casa sua, a patto che il suo animo, mosso da superficiale distrazione, non abbia dimenticato, chissà dove, le chiavi per aprire la porta.
I napoletani sono ovunque, in qualunque meandro di mondo dove si cantano le melodie della “Napoli di ieri e di oggi”, ovunque sia ubicata una pizzeria ed esista un “Gennaro Esposito”, ovunque ci sia qualcuno capace di innescare con una semplice battuta sorrisi e risate sincere. In qualunque cuore esiste la voglia di ricominciare.
Che tu sia di Milano, di Rovigo o di Bolzano, se guardi sinceramente infondo alle tue vene, scorgerai sangue napoletano.
Perché ha ragione “Jovine” quando dichiara che il napoletano non emigra, ma colonizza…